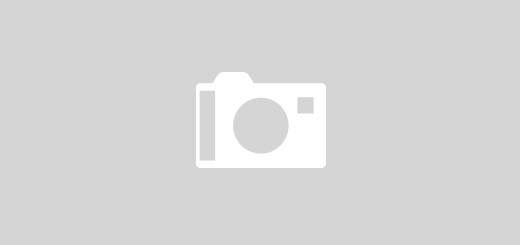Ma veramente gli Stati Uniti hanno bisogno del petrolio venezuelano?
Il ripristino della produzione richiederebbe tempi lunghi e investimenti massicci.
Il Financial Times, sulla base di analisi di Rystad Energy, ha indicato che raddoppiare la produzione venezuelana entro il 2030 richiederebbe circa 115 miliardi di dollari di investimenti, una cifra che, per comparazione, rappresenta il triplo degli investimenti delle due major americane ExxonMobil e Chevron nel 2024.
Prendendo a spunto la netta posizione della Exxon in occasione della riunione convocata alla Casa Bianca per indurre le majors petrolifere ad investire in Venezuela, c’è da chiedersi se e quanto le società petrolifere americane siano disposte a distogliere i loro investimenti da aree meno rischiose per dedicarli al Venezuela.
Pragmaticamente, le società petrolifere che volessero investire in Venezuela si troverebbero a gestire un’infrastruttura fatiscente e obsoleta, un petrolio di pessima qualità, un regime fiscale sfavorevole, corruzione, un quadro legislativo poco chiaro e la mancanza di personale specializzato.
I costi di produzione in Venezuela sono notoriamente alti, i più alti dell’area OPEC riferiti anche ai momenti di auge ed efficienza, dell’ordine di decine di dollari/barile, mentre più recentemente in paesi vicini, come la Guyana, si registrano costi di produzione sotto i 10 dollari al barile in un contesto di minimo “rischio paese”.
Ogni considerazione, economica e non solo strategica, va riportata al rapporto offerta globale/domanda, peraltro con un occhio alla sicurezza ed alla situazione geopolitica: una situazione di relativa abbondanza e di prezzi petroliferi moderati sconta l’incognita e la variabile delle tensioni di alcuni choke points, con l’esempio classico e ricorrente degli stretti di Hormuz attraverso i quali transita quasi il 20% della produzione mondiale di petrolio. Un blocco dei flussi in qualsiasi dei choke points globali farebbe schizzare verso l’alto, i prezzi del greggio, e la sicurezza dei rifornimenti, su rotte corte e protette, è quanto ha avvantaggiato il Venezuela fin dalle guerre mondiali del secolo scorso .
Secondo la IEA (l’Agenzia Internazionale dell’Energia) la domanda globale di greggio dovrebbe aumentare di 700.000 barili al giorno nel 2026, cioè un incremento di meno dell’0,7% della produzione attuale, comunque in un quadro dove il mercato conta su un surplus di offerta di 4 milioni di barili al giorno, tanto che ad inizio anno l’OPEC+ ha deciso di non aumentare le quote di produzione per difendere i prezzi.
In una prospettiva di medio termine, l’IEA e altre organizzazioni prospettano il raggiungimento del picco della domanda di petrolio all’orizzonte 2030, salvo cambi – peraltro all’orizzonte – dell’attuale politica di transizione energetica
Come in tutte le analisi di fattibilità occorre prendere in considerazione i dati negativi, e pertanto dopo la fine del decennio, la domanda di petrolio entrerà in una fase di declino, ed anche se i combustibili fossili non spariranno dal nostro menù energetico e le forniture di greggio rimarranno consistenti, le compagnie petrolifere e i petrostati opereranno in un mercato in riduzione e di maggiore contrasto.
I combustibili fossili rimarranno nel nostro mix energetico, ma il loro contributo e soprattutto la loro valenza politica sembrerebbero destinati a diminuire.

La ricorrente giustificazione (o addebito nei confronti di Trump) per l’intervento in Venezuela è che le raffinerie americane siano costruite per greggi pesanti come quello venezuelano, e che abbiano difficoltà a raffinare petroli più leggeri.
Gli Stati Uniti si approvvigionano già in greggio pesante dal Canada, prodotto delle sabbie bituminose, praticamente lo stesso del Venezuela, e tecnicamente sarebbe possibile modificare le raffinerie americane per permettere la raffinazione di greggi più leggeri, come quelli prodotto domesticamente.
Non si può pensare che l’operazione speciale in Venezuela sia stata fatta né per avere maggiore potere contrattuale nei confronti del Canada né per evitare una modifica alle raffinerie statunitensi (anche se la raffinazione negli USA è in crisi, e deficitaria da anni, per le normative ambientali).
Produzione e raffinazione all’estero potrebbero essere tra le ragioni, ma bisogna considerare i costi associati al Venezuela.
Infine, si può ricordare che l’autosufficienza petrolifera americana è stata raggiunta grazie alla controversa shale oil revolution che ha permesso, in poco più di un decennio, di raddoppiare la produzione statunitense di greggio.
La produzione di shale oil americano ha break-even costs compresi fra 40 e 60 dollari (vicini a quelli venezuelani) e non si capisce perché le compagnie americane dovrebbero andare a produrre un greggio di scarsa qualità in un paese ad alto rischio politico per fare concorrenza al proprio shale oil nazionale.
L’intervento, od azione dimostrativa, su Caracas andrebbe pertanto interpretato in un contesto più ampio, cominciando dal posizionamento geografico del paese come cintura di sicurezza nei Caraibi, e considerando altre risorse, parte accertate ma disponibili solo con grandi investimenti di recupero, altre non solo potenziali ma note, da portare a livello di sfruttamento industriale.
L’operazione speciale in Venezuela non è la fine di un regime, solo quello della dittatura a “marca Maduro”, ed è – con mole incognite – solo l’inizio di una fase di transizione che potrebbe essere caotica e turbolenta, e questo che sta prendendo in considerazione e perturbando il mondo finanziario ed assicurativo, un mondo che deve guardare ad un orizzonte almeno ventennale e non a quello di un mandato.
Anche nell’ ipotesi auspicata, ed apparentemente privilegiata da Trump, qualora il paese non dovesse precipitare nel caos e ci fosse un passaggio di poteri “ordinato” grazie alla disponibilità (tutta da verificare) della “Presidente in funzione” Rodríguez, il ripristino della produzione petrolifera sarà lento, complesso e costoso.
Qualcuno, causticamente, afferma che solo una visione ed un’esperienza immobiliarista come quella di Trump poteva concepire di rilanciare la produzione venezuelana in tempi brevi visto che aumentare la produzione di petrolio in Venezuela sarà più lungo, più costoso e più complicato di mega-immobili, ma Trump riserva sempre sorprese e non bisogna sottovalutare la sua visione strategica a lungo termine.
Detto questo, il controllo della produzione e del regime venezuelano darà agli Stati Uniti una serie di vantaggi geopolitici. Il Venezuela è membro dell’OPEC e il controllo della sua produzione darà de facto, agli Stati Uniti un’entratura nell’influente Organizzazione.
Allo stesso tempo, il controllo del petrolio venezuelano impedirebbe il suo “uso politico”, in primis la sua cessione in termini sempre molto oscuri al regime cubano, indebolendo un “nemico” degli Stati Uniti nell’area (e lo stesso messaggio a “figure” minori ma comunque perturbatrici in centro America, a cominciare dal piccolo Nicaragua, per poi farlo arrivare ai due estremi di Colombia e Messico).
L’instaurazione di un “regime allineato” a Caracas, ben prima di una transizione democratica anch’essa di ricostruzione e di tempi lunghi, permette agli Stati Uniti se non il pieno controllo della regione la possibilità di mettere un freno all’influenza geopolitica della Russia e soprattutto di una Cina che aveva da tempo superato il livello di guardia.
Immagine: USGS
L’articolo Ma veramente gli Stati Uniti hanno bisogno del petrolio venezuelano? proviene da Difesa Online.
Il ripristino della produzione richiederebbe tempi lunghi e investimenti massicci. Il Financial Times, sulla base di analisi di Rystad Energy,…
L’articolo Ma veramente gli Stati Uniti hanno bisogno del petrolio venezuelano? proviene da Difesa Online.
Per approfondimenti consulta la fonte
Go to Source