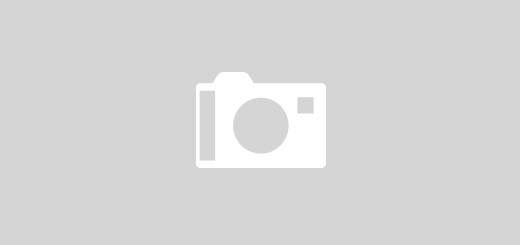L’America volta pagina ma non è detto che per noi sia una buona notizia
I Fratelli Grimm commenterebbero l’attuale situazione internazionale così: “Il 20 gennaio l’Orco venne allontanato, il Bene trionfò e tutti (Europa ed USA) vissero felici e contenti”.
Tranquillizzante, certamente, ma sarà davvero così? I lettori di Analisi Difesa possono verificare che negli ultimi 4 anni lo scrivente si è spesso espresso con toni molto critici nei confronti della politica di sicurezza di Trump e dei suoi effetti negativi sia sulla coesione dell’Alleanza Atlantica sia sulla stabilità del Mediterraneo Allargato. Ciò premesso, non mi aspetto stravolgimenti sostanziali dopo il cambio alla Casa Bianca.
È vero che ad oggi poco si sa dell’impronta che sarà impressa alla politica estera dalla nuova amministrazione statunitense. La campagna elettorale democratica è stata, ovviamente, focalizzata su tematiche di politica interna, di economia, di uguaglianza e diritti delle minoranze (che negli USA non sono numericamente così minoritarie) e moltissimo sul contrasto all’epidemia.
Bisognerà vedere il team di Biden all’opera e, per ora, ben poco sappiamo dell’impatto che avrà in materia “l’uomo forte” della nuova amministrazione USA (ovvero, Kamala Harris).

Ovviamente, occorrerà anche considerare in che misura incideranno sulla politica estera e di sicurezza USA i principali attori coinvolti, ovvero il futuro Segretario di Stato (Tony Blinken, già presente nelle due amministrazioni Obama, che pertanto non dovrebbe costituire una reale incognita e che verosimilmente rappresenterà il ritorno alla normalità dopo la parentesi turbolenta di Mike Pompeo), il futuro Segretario alla Difesa (Lloyd James Austin, un ex generale con esperienze di comando in Iraq e in Afghanistan), il nuovo Direttore della CIA (William J. Burns, con un back-ground diplomatico di grande rilievo, già ambasciatore a Mosca, che ha servito per oltre vent’anni con tutte le amministrazioni sia repubblicane sia democratiche, assumendo incarichi politici di primo piano nelle amministrazioni di Bill Clinton, di George W. Bush e di Barack Obama, dove era il Vice del Segretario di Stato Hillary Clinton e che sicuramente rappresenterà un elemento di competenza e di continuità) e il nuovo National Security Advisor Jacob J. Sullivan (già Senior Political Advisor per la politica estera di Hillary Clinton durante la sua campagna presidenziale del 2016 e già principale negoziatore, insieme con il già citato Burns, nelle trattative riservate che hanno portato alla firma del “Joint Comprehensive Plan of Action” ovvero del Trattato sul Nucleare Iraniano, dal quale poi Trump è unilateralmente uscito).

In termini generali, vista la squadra scelta da Biden, ci si può aspettare dalla nuova amministrazione una forte continuità ideologica con la linea di Barack Obama (di cui Biden è stato vice presidente dal 2009 al 2017 e con il quale aveva, secondo i media, grande comunità di vedute) e, soprattutto, con quella di Hillary Clinton (Segretario di Stato nel periodo 2009-2013) tuttora apparentemente molto influente in casa democratica, alla quale non possono non essere mossi rilievi da noi europei in relazione alla gestione delle “primavere arabe” e della crisi ucraina.
Ovviamente, la nuova amministrazione deve fronteggiare una situazione geopolitica molto complessa, nella quale gli USA non godono più del vantaggio di essere ritenuti l’incontrastata superpotenza mondiale.
Ciò non perché Trump abbia “avvelenato i pozzi” prima di lasciare la Casa Bianca, come molti lo accusano di aver fatto, ma semplicemente perché, nell’indifferenza di Washington, gli USA hanno gradualmente perso la loro premiership economica, politica e militare.
Un processo lento che non è imputabile (solo) all’ultimo inquilino della Casa Bianca ma che è venuto gradualmente a imporsi dall’11 settembre 2001 in poi).
Soprattutto, però, cosa cambierà per noi europei e per noi italiani? Temo che i reali cambiamenti, per gli aspetti che ci riguardano più da vicino, saranno più formali che sostanziali e, talvolta, persino in peggio.

Che ci sia Trump o Biden nello Studio Ovale, il centro di gravità degli interessi geo-politici statunitensi resterà l’Indo-Pacifico. I tempi delle vecchie proiezioni cartografiche di Mercatore, quelle con l’Oceano Atlantico al centro del globo terracqueo, per la Casa Bianca sono superati da decenni.
La Cina resterà la maggior preoccupazione di Washington. Già nell’epoca Obama si parlava di un immaginario G2 “USA – Cina”. Da allora, la minaccia economica e politica di Pechino si è fatta più tangibile (ancor più in epoca pandemica) e recentemente la Cina sta assumendo una dimensione militare che richiede attenzione. Nonostante Biden si sia espresso in termini negativi in merito alla “guerra commerciale“ avviata da Trump nei confronti della Cina sarà difficile che i rapporti tra le due superpotenze possano migliorare.
Biden avrà l’esigenza di ristabilire un credibile ruolo USA nell’Indo-Pacifico e rassicurare le nazioni della regione che temono sempre di più l’arroganza e la crescente espansione cinese, materializzata anche dalla “Belt & Road Initiative” (quella che noi italiani chiamiamo “la nuova Via della Seta”).
L’importanza dell’Indo-Pacifico è dovuta anche al grande peso che hanno le rotte marittime che lo attraversano (rotte sulle quali transitano due terzi dei trasporti mondiali di greggio e la totalità di quelli diretti verso la Cina, oltre a una consistente componente del traffico marittimo mondiale di altre merci).

L’espansione cinese nell’Indo-Pacifico è oggi particolarmente evidente e rappresenta la base anche per la sempre più preoccupante espansione di Pechino nel continente africano.
L’Amministrazione Trump ha gestito i rapporti con la Cina in maniera esclusivamente bilaterale. È da vedere se la nuova amministrazione procederà in maniera analoga. Ovviamente, vi sarebbe la possibilità per gli USA di capitalizzare sui giustificati timori dei paesi della regione e di adottare un approccio multilaterale per il contenimento del dragone cinese.
Nel 2017 gli USA hanno rivitalizzato in tale ottica il QUAD (Quadrilateral Security Dialogue, originariamente creato per gestire gli aiuti post-tsunami del 2005) con Australia, India e Giappone. Peraltro, l’iniziativa è stata poco più che formale. Un approccio multilaterale al confronto con la Cina richiederebbe a Washington di coinvolgere a suo favore i paesi dell’ASEAN (Association of South East Asian Nations).
Però molti di questi, pur consapevoli della minaccia cinese, sono oggi economicamente troppo dipendenti da Pechino e troppo timorosi di eventuali sue ritorsioni a livello economico (o anche militare) per supportare gli USA. D’altronde, ben sanno che la Cina è alle porte di casa loro ed è pronta ad agire con determinazione e senza curarsi del diritto internazionale. La storia recente insegna loro che le promesse di Washington (chiunque ci sia alla Casa Bianca) potrebbero essere sacrificate sull’altare della propaganda elettorale già alle prossime elezioni di “mid-term”.
Non si può sapere come si affronteranno le due superpotenze nel prossimo futuro, ovvero se cercheranno situazioni di compromesso e mediazione nel reciproco interesse immediato (ipotesi forse più probabile) o se andranno allo scontro commerciale, anche se non necessariamente militare. Sicuramente un’indicazione in proposito verrà da come affronteranno il problema Taiwan, perché, come avevano già segnalato, preso atto della mancata reazione occidentale ai fatti d Hong Kong, Taiwan è già nel mirino di Pechino (Il pugno duro di Pechino a Hong Kong è un monito per l’Occidente – Analisi Difesa).
Comunque, l’Indo-Pacifico resterà il centro di gravità per gli USA e, in tale prospettiva, l’Europa resterà periferica e ben poco influente.

È facile prevedere che i rapporti tra USA e Russia diventeranno significativamente più tesi.
I Democratici USA hanno sempre accusato Trump di essere troppo morbido nei riguardi di Mosca e non hanno mai avuto simpatia per Vladimir Putin. Le accuse USA riguardano l’occupazione della Crimea nel 2014, il supporto fornito da Mosca alle popolazioni russofone in Ucraina e quello fornito a Bashar Assad in Siria.
Inoltre, accusano Putin di vari attacchi cibernetici nelle Repubbliche Baltiche e negli USA e di aver tramato per favorire l’elezione di Trump nel 2016. Logico, pertanto, che anche a Mosca non vedano di buon occhio l’arrivo di Biden alla Casa Bianca. Inoltre, ci si può anche aspettare che l’amministrazione Biden attacchi Putin in relazione al mancato rispetto dei diritti umani in Russia (presunto o reale che sia, non importa), in ciò rafforzando la reazione di un popolo profondamente legato ai valori nazionali che tende a non accettare “intromissioni” da parte di potenze straniere.
Nel frattempo, Putin agli occhi di molti (soprattutto nel Mediterraneo Allargato) si sta qualificando quale alleato e sponsor affidabile nel tempo, che (a differenza degli USA) non abbandona i propri alleati per esigenze elettorali. Mosca sta acquisendo l’immagine (più o meno giustificata) di potenza di riferimento in grado di portare le crisi ad una soluzione ricorrendo al giusto mix tra uso della forza e mediazione, come fatto in Siria.
Inoltre, Putin appare l’unico disposto a contrastare le azioni piratesche del “sultano” Erdogan, che preoccupano vari paesi rivieraschi del Mediterraneo. Certo la credibilità di Putin affonda le sue fondamenta nella scarsa credibilità delle amministrazioni USA che si sono succedute recentemente e nel modo con cui sia Obama sia Trump hanno troppo spesso abbandonato senza remora alcuna i loro alleati locali (dall’Afghanistan alla Siria e all’Iraq).
La Russia di Putin, a fronte di tale atteggiamento USA, potrebbe stringere ulteriormente i propri legami con la Cina in un’ipotetica morsa per contenere, o almeno limitare, le possibilità di azione di Washington. Lungi dal voler enfatizzare il significato politico delle recenti imponenti esercitazioni militari congiunte russo-cinesi (quali Vostok 2018 e Joint Sea 2019), non può essere comunque negato che si trattasse di un messaggio forte indirizzato a Washington.

Inoltre, la Russia ha oggi una posizione abbastanza baricentrica rispetto alle principali situazioni di crisi e recentemente ha sensibilmente esteso la sua capacità d’intervento anche nel Mediterraneo e di ciò noi italiani dobbiamo, volenti o nolenti, tener conto.
Ovviamente, Cina e Russia, sia pure in maniera e in misura diversa, puntano a incrementare ulteriormente il proprio peso geo-politico.
Facendo un paragone olimpico potremmo dire che la Cina punti alla medaglia d’oro (e a non avere una disturbante presenza americana nell’Indo-Pacifico), mentre la Russia aspiri almeno a salire sul podio dei primi tre. Peraltro, entrambe per raggiungere i propri obiettivi devono erodere la potenza (economica, politica, militare) degli USA. Una politica lungimirante di Washington dovrebbe tendere a prevenire una coalizione tra le due potenze rivali, anche a costo di “non vedere” i peccati dell’avversario meno temibile (Putin). Ma un tale approccio pragmatico potrebbe risultare indigesto a molti politici USA, sia repubblicani sia soprattutto a quelli democratici.
Se si esclude il grande successo nel riavvicinamento tra Israele e mondo arabo, la presidenza Trump è stata particolarmente assente nelle crisi che da anni travagliano Nord Africa e Medio Oriente. Tale vuoto ha consentito l’imporsi di attori volitivi e disposti ad accettare rischi per conseguire i propri obiettivi, quali Russia e Turchia. Per tornare a contare nel Mediterraneo Allargato gli USA dovrebbero ridimensionare questi due attori e ciò non sarà facile.
Se il riferimento per la prossima amministrazione dovesse essere costituito dalla politica USA nella regione durante i due mandati presidenziali di Obama (2009-2017) e dall’atteggiamento USA nei confronti della crisi libica e di quella siriana, non ci si potrebbe certo aspettare un impegno serio e duraturo di Washington. Speriamo che non sia così.

Nonostante le sue assenze, il grande merito dell’Amministrazione Trump in questa regione è stato quello di aver favorito la creazione di un fronte anti -Iran che accomuna Israele e le principali monarchie sunnite. Un risultato insperato che ha contribuito a isolare ulteriormente Teheran, rivelandosi elemento di stabilità per l’intera regione.
A suo tempo, l’amministrazione Obama si era dimostrata disponibile nei confronti del così detto “Islam Politico”, che è legato anche alla Fratellanza Musulmana, mentre appariva più fredda di quella Trump nei confronti delle monarchie sunnite (Arabia Saudita, ma anche Emirati Arabi e Kuwait).
Il grande sforzo dell’amministrazione Obama nella regione era stato quello di recuperare il rapporto con l’Iran, anche per meglio controllarlo. La nomina ai vertici di CIA e di NSA di due dei principali artefici degli accordi sul nucleare iraniano (Burns e Sullivan) sono un evidente indizio di una nuova apertura nei confronti degli Ayatollah.
Si vedrà quale sarà il risultato dell’atteggiamento più dialogante che Washington presumibilmente avrà con Teheran, ma c’è il rischio che la leadership iraniana, come qualsiasi leadership totalitaria, tenda a considerare il nuovo atteggiamento USA come una eclatante manifestazione di debolezza. Né tale atteggiamento potrà essere apprezzato dalle monarchie sunnite o da Israele, che restano i principali potenziali alleati dell’Occidente nella regione.
I rapporti tra USA e Unione Europea saranno sicuramente più cordiali e improntati (a differenza di quanto è stato negli ultimi quattro anni) al reciproco rispetto, almeno nella forma se non nei contenuti. Le vie del dialogo saranno certamente più aperte. Ciò premesso, l’Unione Europea resta un grande competitor economico degli USA.
Resterà invariata la tendenza USA a dialogare con singoli paesi membri anziché con l’Unione nel suo complesso e, comunque, per le problematiche di difesa e sicurezza che interessano il nostro continente, gli USA continueranno a guardare alla NATO anziché all’UE, che dopo la Brexit sentono ancora meno “amica” di prima.

Già l’amministrazione Obama vedeva con preoccupazione il processo d’integrazione europea, che poteva essere ritenuto pericoloso non a livello politico o militare ma certamente a livello economico e monetario anche valutando che l’euro avrebbe in futuro potuto minacciare la posizione del dollaro come moneta di scambio internazionale. Secondo alcuni osservatori l’estrema instabilità politica che durante la presidenza Obama si è venuta a creare ai margini dei confini europei (dall’Ucraina alla Siria, alla Libia e in definitiva a tutto il Sahel e Nord Africa) non sarebbe stata del tutto sgradita a Washington, proprio perché avrebbe tenuto impegnato un pericoloso competitor commerciale evidenziandone la fragilità politica e costringendolo ad investire di più sulla propria difesa. Una tesi sostenuta ad esempio da George Friedman.
Pur senza ipotizzare complotti ai danni dell’UE o una improbabile regia americana dietro alla destabilizzazione del Nord Africa e del Medio Oriente, non si può negare che tali crisi, tuttora perduranti, costituiscano un grave problema per una UE incapace di assumere qualsiasi posizione al riguardo.
È probabile che la nuova amministrazione dimostri, almeno nella forma, maggior considerazione per l’Alleanza Atlantica. Peraltro, resteranno immutate le pressioni sugli alleati per aumentare il proprio contributo all’Alleanza e per incrementare le proprie spese militari. Del resto l’impegno a dedicare almeno il 2% del PIL per la Difesa ed almeno il 20% del budget della Difesa alla ricerca, sviluppo e acquisizione di sistemi d’arma fu assunto su pressione statunitense durante il Summit di Cardiff del 2014, in piena presidenza Obama.
Inoltre, è prevedibile che i paesi membri che più temono minacce da est (Repubbliche Baltiche, in primis, ma anche Polonia e Norvegia) faranno leva sulle posizioni critiche verso la Russia della nuova amministrazione per ottenere un più marcato impegno dell’Alleanza sulla sua frontiera orientale. In tale contesto, potrebbero verosimilmente aver nuovo impulso le iniziative tendenti all’ammissione di Ucraina e Georgia nella NATO. Iniziative che Mosca ritiene ostili e che rinforzano la sensazione di “assedio da parte della NATO” percepita dai russi.
È chiaro che una polarizzazione Est-Ovest dell’Alleanza rimanderebbe in secondo o terzo piano la già limitata attenzione che la NATO sta oggi dimostrando per il così detto “fronte sud” (che è quello di maggior interesse per gli italiani)

In conclusione, i rapporti tra le die sponde dell’Atlantico saranno nei prossimi quattro anni sicuramente più cordiali (almeno nella forma) e non ci dovremo aspettare G7 traumatici come gli ultimi a cui abbiamo assistito, ma gli interessi geopolitici degli USA costringeranno la Casa Bianca a continuare a guardare soprattutto alla Cina e all’Indo-Pacifico.
Il probabile peggioramento dei rapporti con Mosca porterà l’Alleanza Atlantica a guardare sempre più verso Est anziché a Sud, preparandosi ad opzioni “articolo 5” più che alla prevenzione e gestione delle crisi che risulterebbero più nell’interesse dell’Italia in quanto paese cerniera tra Europa e Nord Africa.
Il Mediterraneo Allargato nel migliore dei casi (ovvero se verranno almeno evitate operazioni “fire and forget” come quella in Libia nel 2011) rischia di restare una scacchiera dove continueranno senza grandi problemi a muovere le loro pedine il Sultano e lo Zar. Forse “l’Orco” sarà anche sparito, ma il lieto fine non sembra essere all’orizzonte.