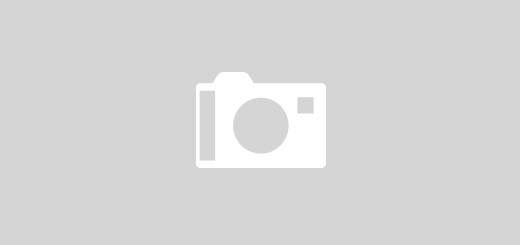Afghanistan addio
In seguito agli accordi di Doha del febbraio scorso tra Stati Uniti e Talebani e all’annuncio del ritiro dei militari italiani dal paese asiatica entro la metà del 2021 il generale Giorgio Battisti fa il punto sulla missione più lunga, anche per l’Italia, della storia militare recente.
Battisti ha prestato servizio in Afghanistan in diverse circostanze tra il dicembre 2001 e il 2014:
- dicembre 2001 – maggio 2002, quale comandante di ITALFOR 1 (ho aperto la missione);
- febbraio – giugno 2003, quale comandante della missione Nibbio 1 e del contingente italiano in ISAF;
- luglio – dicembre 2007, quale capo di stato maggiore Supporti al comando dell’International Security Assistance Force (ISAF)
- gennaio 2013 – gennaio 2014, quale capo di stato maggiore del comando dell’ISAF e comandante del corpo di reaziona rapida NATO NRDC-ITA.

La notizia dell’accordo di Doha non ha avuto in Italia l’eco che avrebbero meritato, sia forse per il coronavirus e l’emergenza socio-economica che interessano il Belpaese sia per il tradizionale distacco di gran parte della politica e dei media sui temi che riguardano oggigiorno l’Afghanistan, malgrado siano ancora presenti circa 800 soldati italiani.
Il processo del ritiro del contingente è visto con apatia e indifferenza, dimenticando la perdita di 53 militari e di una cooperante italiana, oltre alla giornalista Maria Grazia Cutuli, e circa 700 feriti e mutilati, sacrificatisi per evitare che l’Afghanistan ritornasse ai tempi bui del regime talebano, come più volte sottolineato dai leader politici nazionali e internazionali. L’accordo, considerato un gran successo sia dall’Amministrazione Trump sia dal Segretario Generale della NATO, offre diversi spunti di approfondimento.

Innanzitutto, appare squilibrato in quanto è il risultato di un’intesa bilaterale (USA-Talebani) in un conflitto che vede coinvolti almeno tre attori principali, senza dimenticare la NATO, e che non ha minimamente interessato il legittimo Governo afghano, eletto con democratiche (seppur imperfette) consultazioni elettorali, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto dagli stessi Americani.
Gli Stati Uniti e il governo di Kabul, inoltre, sono legati dal dicembre 2014, alla conclusione della missione ISAF, da un Bilateral Security Agreement (BSA), che definisce i termini, i ruoli e il sostentamento che gli USA devono fornire all’Afghanistan. Analogo accordo è stato redatto dall’Alleanza Atlantica (NATO SOFA).
La conclusione di un simile accordo in assenza di un processo di pace tra Afghani – i Talebani non riconoscono il Governo di Kabul – rischia di consegnare il Paese agli “studenti islamici” che ritengono, con il ritiro delle forze straniere, di essere i “veri vincitori” del conflitto, rivendicando la re-instaurazione dell’emirato islamico.

Ciò richiama alla memoria il ritiro degli Stati Uniti dal Vietnam nel 1973, seguito due anni dopo dalla vittoria comunista (aprile 1975). All’epoca Henry Kissinger, il negoziatore di Washington, aveva preteso un “intervallo decente” prima che il Vietnam del Nord invadesse “apertamente” il Vietnam del Sud.
Più recentemente, ricorda il ritiro unilaterale voluto dal Presidente Obama dall’Iraq nel 2011, che ha lasciato il Paese in mano a un governo filo iraniano e che ha creato le premesse per la nascita e l’ascesa dell’ISIS, costringendo gli USA a ritornare nella Regione solo pochi anni dopo.
La decisione statunitense è sicuramente scaturita dalla situazione di stallo militare nella condotta delle operazioni (nessuna delle due parti riesce a prevalere sull’altra) e dalle promesse elettorali del Presidente Trump, ma è anche la conseguenza del “triage strategico” di Washington.
Si tratta, in sostanza, della revisione delle priorità in politica estera e conseguente riallocazione delle risorse dove sono ritenute più necessarie (Teatro del Pacifico). Nella America first di Donald Trump, i Talebani sono il “male minore” con cui venire a patti, come è accaduto in Siria con i Turchi: gli interessi nazionali trascendono dalla fine dei combattimenti!

Una logica realistica e bipartisan (anche il Presidente Obama aveva questa visione strategica) che sembra accettare che non tutte le “guerre americane” possono terminare con una vittoria, come nella Seconda Guerra Mondiale, e riconoscere che altre possono concludersi con “un pareggio”, come in Korea (1950 – 1953), anche se in entrambi i casi consistenti forze americane sono ancora presenti sul posto. Resta da chiedersi se rimarranno in Afghanistan gli assetti dell’Operazione di controterrorismo Freedom’s Sentinel ?
Si tratta di un ulteriore duro colpo alla credibilità americana a livello mondiale, già minata con l’abbandono dei Curdi, con indebolimento delle sue capacità di deterrenza e della volontà di sostenere i Paesi alleati in difficoltà: nessuna Nazione potrà più fidarsi degli USA.
Un “futuro” che assomiglia sempre più a un ritorno alla situazione antecedente l’intervento dell’ottobre 2001: un santuario dell’Islam radicale e terroristico.
Dato per scontato che la pace si fa con il nemico (e non con l’amico) e che prima o poi si deve tornare a convivere con chi si è combattuto (come fanno Stati Uniti e Vietnam), sarebbe stato più opportuno trattare da una posizione di forza per ottenere migliori condizioni dall’accordo.

La conclusione di una missione internazionale, senza che abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, è sempre oggetto di polemiche e critiche in quanto è considerata uno inutile spreco di vite umane e di risorse economiche (vds. Op. UNOSOM in Somalia 1992 – 1995) se non un ulteriore problema per la stabilità regionale (vds. l’attacco alla Libia di Gheddafi nel 2011).
Sul piano prettamente militare il ritiro delle forze straniere (39 contingenti) – retrograde (materiali) e redeployment (forze) – dovrebbe avvenire secondo il principio all together in & together out (il ripiegamento unilaterale dall’Iraq disposto dal Premier spagnolo Zapatero nel 2004 ha leso fortemente l’immagine delle forze armate di Madrid) e basarsi su di una complessa e articolata pianificazione operativa, logistica e tecnica.
I Talebani non sono una organizzazione terroristica o di insorti monolitica con unica linea di comando, come erano a suo tempo i Vietminh e Vietcong (che avevano alle spalle una rigida e disciplinata struttura politico-ideologica comunista). Non tutti i gruppi di insorti/terroristi condividono i termini del trattato di pace.

Secondo valutazioni statunitensi (D. Petreus and V. Serchuk, The U.S. Abandoned Iraq. Don’t Repeat History in Afghanistan, The Wall Street Journal, Aug. 9, 2019) sono circa 20 le organizzazioni terroristiche attive ai due lati della Linea Durand, che segna il confine tra Afghanistan e Pakistan. I recenti rapporti (20 gennaio e 19 maggio 2020) del UN Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, responsabile del monitoraggio dei gruppi terroristici nel mondo, conferma, come nei precedenti rapporti, lo stretto legame – per i reciproci benefici – tra al-Qaida e i Talebani (rifornimenti e addestramento in cambio di protezione).
Il 28 agosto 2019, in una conferenza stampa al Pentagono, il Generale Dunford, Capo dello Stato Maggiore Congiunto, aveva affermato: «Gli Afghani non sono ancora in grado di gestire da soli il livello di violenza che si registra nel Paese. Non userò la parola ritiro ora, direi che faremo in modo che l’Afghanistan non sia un santuario per il terrorismo e tenteremo di portare pace e stabilità nel Paese».
Uno dei principali ostacoli alla sconfitta dei Talebani è dovuto sia all’instabilità del governo afghano e alla sua incapacità di elaborare pianificazioni efficaci e preventive per contrastare l’azione avversaria sul terreno sia al rafforzamento delle forze di sicurezza per il ripiegamento dei contingenti NATO.
Sebbene la corruzione sia presente nei vertici delle istituzioni afghane e abbia anche infiltrato le forze di sicurezza, le ANSDF hanno combattuto e combattono con bravura e spirito di sacrificio (1.000 caduti al mese nell’ultimo periodo). Sono tuttavia lente nel contrastare gli attacchi e la reazione avviene spesso quando i Talebani hanno già circondato i centri urbani o preso il controllo degli edifici più importanti, in quanto prediligono un atteggiamento attendista e di guarnigione (presidio posizioni).

Tali difficoltà sono dovute verosimilmente alla presunzione di aver voluto addestrare le forze militari e di sicurezza afghane (ANSDF) secondo i canoni occidentali, senza tener conto che per formare una Forza Armata dalla struttura convenzionale servono anni e una solida e professionale classe di comandanti, soprattutto quando la mentalità e la cultura è completamente diversa, come si è già visto con le Forze Armate irakene.
Le forze afghane, poi, sono composte da personale con diversi background: i mujaheddin della lotta antisovietica, i militari provenienti dalle Forze Armate del passato regime comunista e i più giovani formatisi presso le scuole militari NATO, pakistane e indiane.
Un insieme di mentalità e di diversa formazione che non sempre si raccordano tra di loro e spesso generano incomprensioni a livello d’impiego.
A tutto ciò concorre anche l’analfabetismo che amplia i problemi sopra citati. Quarant’anni di conflitti hanno condizionato il sistema scolastico locale e i grandi progressi compiuti negli ultimi anni, che hanno sicuramente ridotto l’entità del fenomeno, non l’hanno ancora risolto.

Sarebbe stato sicuramente più redditizio sviluppare le loro naturali doti combattive addestrandoli secondo i metodi e la cultura locali. Del resto i Talebani, anche loro Afghani, combattono secondo i tradizionali sistemi.
Gli Afghani sono abituati da secoli alla guerriglia, agli attacchi improvvisi, alle imboscate. Un modo di combattere che è l’espressione della cultura e dello spirito di un popolo.
È questo il risultato di un approccio marcatamente etnocentrismo (occidentale), che privilegia i valori della nostra cultura per analizzare le altre culture, in particolare le più lontane, e considera i nostri valori come universali. Il Generale russo Makhmut Garayev (1923 – 2019), ultimo consigliere militare del Presidente Najibullah della Repubblica Democratica dell’Afghanistan (1989 – 1991), ha affermato: «bisogna prendere gli Afghani come sono e non come noi vorremmo che fossero».
Verosimilmente si diffonderà tra le forze di sicurezza afghane la convinzione di essere state abbandonate con il rischio di un aumento di episodi di green on blu, ovvero azioni di fuoco degli stessi militari locali nei confronti delle forze internazionali.
Uno studio condotto nel 2012 su questo fenomeno (c.d. insider attacks) ha evidenziato che uno dei motivi era dovuto alla percezione da parte degli Afghani di sentirsi traditi e abbandonati dal ritiro dei militari di ISAF (iniziato quell’anno).
Un nuovo Afghanistan….per i Talebani?
L’Afghanistan che i Talebani ambirebbero a governare è completamente diverso da quello che hanno lasciato nell’ottobre 2001. Il Paese, con grandi sacrifici e con un aiuto senza precedenti della Comunità Internazionale, ha fatto passi da gigante per recuperare gli effetti di oltre 40 anni di guerre. Un processo che richiede tempo e un cambio di mentalità – si spera – nelle nuove generazioni (condizione che ha interessato anche l’Europa dopo le due guerre mondiali).

Da sottolineare che oltre il 50% degli Afghani ha meno di trent’anni e non sa cosa voglia dire vivere in tempo pace.
Permangono atavici contrasti interni dovuti a secolari conflitti tribali per controversie dovute alle proprietà di terreni da coltivare, ai pascoli e alle sorgenti d’acqua, ed etnici tra sunniti e sciiti (Hazara). Non si può, in sostanza, imporre dall’esterno la pace a chi non la vuole.
Il governo afghano ha messo in atto misure straordinarie nella lotta alla corruzione per arginare questo fenomeno che rappresenta – da sempre – un malcostume endemico in tutti gli strati della società (“modello relazionale” non percepito, sino ad un certo limite, come un aspetto negativo da contrastare) e un rischio significativo per la stabilità del Paese, in quanto inficia, inevitabilmente, la fiducia nell’apparato istituzionale da parte della popolazione e l’immagine stessa dell’Afghanistan agli occhi dei partner internazionali.
Tra l’altro, quanto più è alta la percezione che l’assistenza esterna è destinata a diminuire nel prossimo futuro, tanto più il personale politico-amministrativo è incline ad adottare “politiche predatorie” di breve periodo.
Un problema sociale dovuto anche alla Comunità Internazionale che non sempre ha controllato la gestione e l’impiego dei fondi e la distribuzione aiuti.

Resta da capire cosa ne sarà del rispetto dei diritti conseguiti dai cittadini afghani e delle faticose conquiste democratiche ottenute in questi ultimi 20 anni e, in particolare, del ruolo sociale delle donne.
Le donne, che in questi anni sono state sempre più presenti nella vita pubblica e privata afghana, rischiano di essere le grandi perdenti dell’accordo di Doha e ritornare ad essere virtualmente cancellate dalla società (trattamento secondo i valori della religione islamica).
L’eventuale ritorno dei Talebani rischia, inoltre, di provocare un ulteriore flusso di rifugiati, in aggiunta ai 5 milioni già sfollati nei 40 anni di confitti, nel timore del ripristino di un regime fondamentalista e repressivo, soprattutto per le popolazioni sciite come gli Hazara, perseguitate duramente nel periodo in cui sono stati al potere, e la minoranza Hindu.
L’invio dei contingenti militari avrebbe richiesto un disegno politico ampio e condiviso (comprehensive approach) che non sempre si è verificato per la prevalenza degli interessi e priorità nazionali o di parte.
L’esperienza italiana
Sul piano prettamente militare il conflitto afghano è risultato un importante “momento” di forte crescita professionale per le Forze Armate italiane, e per l’Esercito in particolare, soprattutto per i giovani Quadri: la guerriglia, come ha sottolineato Roger Trinquier negli anni Sessanta, è una guerra per Tenenti e Capitani ( R. Trinquier, Modern Warfare. A French view of Counterinsurgency, p. 92, London 1964).
Un case study che ha interessato tutto lo spettro delle operazioni militari e che ha visto la condotta di una operazione di Peace Enforcement concomitante a una di Peace Building,

È stata un’operazione che ha permesso di ri-acquisire i “fondamentali” (dimenticati dopo il 1945) delle esperienze italiane maturate in oltre 80 anni di operazioni di controguerriglia condotte in scenari assolutamente diversi tra loro.
Anche se alcuni dei principali Paesi occidentali si stanno organizzando per sostenere un conflitto simmetrico ad alta intensità che potrebbe scatenarsi nel prossimo futuro ( N. Guibert, L’armée de terre française envisage de futurs affrontements «Etat contre Etat», Le Monde, 17 juin 2020), le esperienze maturate in Afghanistan saranno sicuramente utili per prepararsi in modo più consono ad affrontare le sfide che si possono presentare (non è sempre possibile scegliere le guerre da combattere).
La lettura specialistica attuale degli studi strategici si riferisce al concetto di Guerra Ibrida, quale modalità di condurre un conflitto utilizzando metodi e personale convenzionale (Forze Armate) in combinazione con minacce non convenzionali (guerriglia, terrorismo, conflitti etnici, guerre per procura, sovversione, migrazione, disordine criminale, risorse di controllo e istituzioni deboli).

Oltre ad approntare il punto di situazione sulle attività/risultati dei nostri contingenti in Afghanistan in questi vent’anni, che potrebbe servire al livello politico (responsabile delle decisioni nazionali) per sostenere le motivazioni del nostro impegno in quel Paese, procederei per elaborare un documento (pratico e applicabile) sulle TTP da seguire nelle operazioni contro-insurrezionali COIN, soprattutto per quanto riguarda la: cultural awareness, modalità di condotta tecnico-tattiche (shape, clear, hold, build and transfer, scorta convogli, search & rescue, presidio di FOB, interventi joint, ecc.), comprehensive approach, ruolo centrale della popolazione, ecc..
Conclusioni
L’attuale situazione impone alcuni spunti di riflessione:
- il ritiro può essere sfruttato e propagandato dagli integralisti islamici quale immagine del fallimento e della debolezza del mondo occidentale;
- il ritiro dall’Afghanistan è una sconfitta politica, e non militare, di tutta la Comunità Internazionale e di ogni Paese che ha partecipato. Occorre evitare che la “colpa” del fallimento venga fatta ricadere sui militari);
- i governi usano i “principi” in ragione dei loro interessi e sono quasi sempre subordinati agli imperativi del realismo politico;
- la storia militare dovrebbe insegnarci a considerare la cultura di un popolo con maggiore attenzione;
- è necessario chiedersi cosa succederà alle forze di sicurezza afghane e a tutti gli Afghani (e loro famiglie) che hanno collaborato e combattuto con le forze multinazionali, tra cui gli interpreti?
- cogliere l’opportunità di raccogliere in modo coerente e lineare le conoscenze e gli insegnamenti maturati in questa particolare forma di combattimento per dare origine a uno specifico corpo dottrinale, per evitare che questa complessa operazione sia ricordata tra qualche anno unicamente nelle memorie dei veterani e negli studi dei pochi storici interessati alla materia.
Foto: Us DoD. ISAF, Emirato dell’Afghanistan e Difesa.it