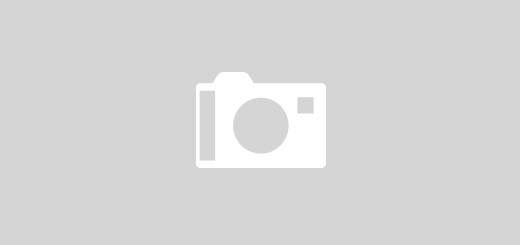Afghanistan: una narrazione diversa per le scelte decisive della comunità internazionale
di Maurizio Delli Santi (membro International Law Association e dell’Associazione Italiana di Sociologia)
Nei discussi accordi di Doha c’ era una condizione che è sfuggita ai più, ma che è assolutamente fondamentale ricordare: un comma vincolava la validità dell’accordo alla ratifica del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e questa è regolarmente avvenuta il 10 marzo 2021, con il voto unanime della Risoluzione 2513. Una clausola che rende infondate le accuse rivolte
agli Stati Uniti di aver assunto una decisione unilaterale e denuncia la miopia di chi si ostina non voler ammettere un dialogo della comunità internazionale con i leader Talebani, perché notoriamente iscritti nelle liste internazionali del terrorismo. Ma altre riflessioni, anche sociologiche, sulle cause del successo dell’avanzata dei Talebani possono orientare meglio le scelte della comunità internazionale sull’ Afghanistan.
I lettori più attenti alle questioni internazionali sanno quanto sia importante non affidarsi ai soli commenti dei media nazionali. Anche per una evidente esigenza di sintesi richiesta dalle pagine dei giornali, i resoconti si presentano certamente efficaci e suggestivi, ma talvolta sono anche piuttosto uniformi o ripetitivi sui mainstream del momento. E, allora, anche per il caso dell’Afghanistan è opportuno affacciarsi alla lettura delle analisi internazionali, per comprendere alcuni aspetti dello stato delle cose meno noti, ma forse non meno significativi ad una attenta interpretazione, anche per orientarsi sulle linee d’azione più concrete e plausibili da intraprendere.
Una prima riflessione ci viene dalla lettura di un contributo di Goerges Lefeuvre, ex consigliere dell’Unione europea per il Pakistan, che sottolinea su Le Monde Diplomatique l’importanza di rileggere il testo originale degli ormai famosi Accordi di Doha, sottoscritti durante la presidenza Trump il 29 febbraio 2020. Si tratta di un testo che non è affatto segreto (è consultabile anche sul link del Parlamento europeo ) o per lo meno ha una parte ufficiale ben chiara ed esplicita, in cui vanno evidenziati alcuni aspetti probabilmente non sufficientemente posti in risalto dalla stampa italiana.

Cominciamo dal titolo “Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America was signed on 29 February 2020”. Qui si evidenzia dunque la denominazione di “Accordo per portare la pace in Afghanistan”, un fine che va tenuto presente rispetto alla situazione attuale di conflitto interno tra i talebani e la resistenza del Panshir.
Ha pure rilievo la dizione adoperata per indicare come parte dell’accordo l’Emirato Islamico dell’Afghanistan con la precisazione “che non è riconosciuto dagli Stati Uniti come Stato”, mentre “is know as Taliban”, letteralmente “è noto come Talebani”.
La formula è poi richiamata per intero in vari passaggi per ribadire il concetto nelle quattro parti dell’accordo che riguardano: 1) le garanzie dei talebani di non dare sostegno a qualsiasi entità – e si fa riferimento espresso ad Al Qaeda – che minacci la sicurezza degli USA e dei loro alleati; 2) gli impegni degli USA sul ritiro calendarizzato al 31 di agosto; 3) ulteriori garanzie anche riferite alle fasi di ulteriori negoziazioni interne all’Afghanistan (“intra-Afghan negotiations with Afghan sides”); 4) l’impegno a perseguire negli intra-Afghan negotiations il “cessate il fuoco permanente e globale”.
Di particolare rilievo nell’articolato sono poi le previsioni più specifiche riferite al rilascio dei prigionieri da entrambe le parti entro tre mesi e alla revisione delle sanzioni con l’assenso del Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite. Per ultimo, non certo per ordine di importanza viene anche sancito l’impegno comune nel ricercare relazioni positive per sostenere, anche economicamente, un “nuovo governo afghano che sarà costituto a seguito del dialogo e dei negoziati intra-afghani”.
È questa una previsione cruciale che avrebbe consentito una maggiore possibilità di manovra della comunità internazionale se il governo uscente di Ashraf Ghani non si fosse eclissato, ma potrebbe essere una clausola ancora da richiamare di fronte all’attuale situazione che vede comunque i talebani disposti a negoziare un governo più inclusivo.

Infine, c’ è poi una condizione che è sfuggita ai più, ma che è assolutamente fondamentale: un comma vincola la validità dell’accordo alla ratifica del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa è regolarmente avvenuta il 10 marzo 2021 con il voto unanime della Risoluzione 2513 sull’ Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the United States of America and the Taliban.
Tutto ciò la dice lunga allora sull’ipocrisia di quanti hanno accusato gli Stati Uniti di aver assunto una decisione unilaterale e ancora si ostinano a non voler ammettere un dialogo della comunità internazionale con i leader Talebani, che invece compaiono già come “parte” in un accordo ratificato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Ma proseguiamo oltre nella lettura di un’altra analisi internazionale, quella di Adam Bazko, affiliato al Centre national de la recherche scientifique e al Centre de recherches internationales, e Gilles Dorronsoro, del Centre européen de sociologie et de science politique. I due ricercatori hanno cercato di analizzare i vari aspetti che avrebbero determinato la vittoria attuale dei talebani e hanno posto subito l’accento su uno dei tanti luoghi comuni con cui si è data per assodata quella che per i due analisti è invece una “visione erronea dell’Afghanistan”. Si tratta in altri termini del mainstream basato su “un’antropologia immaginaria che ha strutturato la società afghana su base localista nei suoi interessi e restia a ogni forma di presenza statale”.
Insomma si è insistito per troppo tempo sullo stereotipo del presunto tratto prevalente del tribalismo dei pashtun e della società afghana, che invece secondo gli autori sarebbe tutt’altro che scontato e affatto insito nelle aspirazioni delle popolazioni, che invece anelerebbero ad un governo centrale che assicuri soprattutto un sistema di welfare e di giustizia.
Bazko e Dorronsoro sono quindi piuttosto critici nei confronti di questa etnografia approssimativa, che a loro avviso avrebbe indotto le istituzioni straniere, in particolare la componente militare statunitense e occidentale in generale ma anche le altre organizzazioni governative, ad aggirare gli organi centrali afghani e a favorire l’elemento locale, fino a parcellizzare il sistema degli aiuti e degli appalti facendo riferimento alle varie entità locali o alle piccole assemblee. In definitiva, si è trattato di un sistema perverso – ad avviso degli autori consapevolmente ricercato da molti occidentali – che ha alterato il potenziale rafforzamento delle autorità centrali in nome di una non riconosciuta volontà di autonomia locale.

E su questo sistema avrebbero tratto profitto lobbies “dedite ad attività a cavallo tra il businnes e l’impegno umanitario”, soggetti stranieri e imprenditori delle varie etnie, uzbeche, hazare o tagike che ora sarebbero a capo delle varie rivendicazioni etnico-nazionali.
Cosicché uno dei motivi del successo dell’avanzata dei talebani è stato costituito proprio dalla capacità, a partire dal 2016, di aver saputo coagulare le varie etnie, ponendo nel consiglio supremo di comando dodici membri, con leader tratti in netta prevalenza dall’elemento pashtun, e poi con un tagiko, un uzbeko e un turkmeno, rifiutando così l’impostazione etnicistica e riproponendo con forza un’idea unitaria del nazionalismo afghano.
Al di là di ogni tara ideologica che in questi casi va fatta per non accodarsi ai temi dell’antiamericanismo e delle “responsabilità dell’occidente neocolonialista”, questo approccio andrebbe riscontrato da un approfondimento che forse potrebbe investire più responsabilmente gli analisti delle principali agenzie di sicurezza, ma soprattutto gli organismi preposti alla valutazione degli assetti istituzionali delle Nazioni Unite e dell’OSCE.
A loro dovrebbe spettare, infatti, la definizione di quale tipo di organizzazione sarebbe più confacente per l’attuale situazione dell’Afghanistan, se quella di uno Stato centralizzato, seppure con criteri di moderata autonomia e rappresentanza dei distretti, ovvero di uno Stato basato su un vero e proprio di modello federale o regionale.
Ai due ricercatori si deve poi un’altra riflessione che appare più facilmente riscontrabile e che probabilmente delinea una priorità d’intervento su cui definire il nuovo assetto istituzionale dell’Afghanistan. Si tratta dell’altro motivo del successo dei talebani: questi si sono radicati nelle campagne istituendo un governo ombra con governatori, responsabili delle scuole, della sanità e dei rapporti con le Ong, e soprattutto hanno nominato dei loro giudici in tutti i distretti.

Si tratta di un vero e proprio sistema di “tribunali ombra” che giudica con le regole pashtun e della sharia, agli occhi delle popolazioni rurali senz’altro più imparziale, efficiente e risoluto di quello distante, capzioso, lento e corrotto del sistema giudiziario ufficiale. In definitiva è la conferma della validità della tesi della “eterogenesi dei fini” dello psicologo Wilhelm Maximilian Wundt, secondo il quale le azioni umane possono riuscire a fini diversi da quelli che sono perseguiti dai soggetti che le compiono.
Di fronte alla volontà degli Stati Uniti – e dei suoi alleati – di ricostruire la forza di uno Stato, nei fatti sin sono aggirate le istituzioni centrali, ne è stata consentita la corruzione, e tutto questo mentre i talebani si andavano affermando come vera autorità statale, informale ma efficiente e capace di rappresentare per molti afghani soprattutto l’immagine del diritto.
Ora, la sfida che spetta alla comunità internazionale non è affatto facile, e di certo l’universo talebano ha anch’esso evidenziato le grandi contraddizioni che al suo interno ora si vanno esasperando nel momento in cui si confrontano con le responsabilità di un governo reale.
Gli ultimi resoconti sull’Afghanistan riferiscono di uno scontro cruciale che vedrebbe la componente più moderata del governo talebano facente capo al vicepremier Baradar soccombere rispetto a quella più radicale del ministro dell’interno Sirajuddun Haqqani, leader dell’omonimo clan ritenuto vicino ad Al Qaeda e persino filo-Isis. Diversi analisti parlano di un rischio sempre più incombente di una guerra civile, per cui sarebbe necessario un intervento tempestivo almeno dell’azione diplomatica della comunità internazionale, per tutelare la popolazione.
Ci sono importanti scadenze ad ottobre, fra cui la convocazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il vertice del G20, che si sta cercando di allargare anche ad attori esterni, come il Pakistan, il Qatar, l’Iran, la Turchia e ad altri paesi arabi, nonché alle repubbliche asiatiche ex sovietiche confinanti, che sono state già interessate da un programma di aiuti europei per sostenere i primi flussi dei rifugiati afghani.

Tuttavia ogni ulteriore attesa comporta rischi gravissimi per l’aggravarsi della deriva autoritaria e oscurantista, se non anche per il deflagrare di un conflitto interno ancora più deleterio per la popolazione civile, di cui potrebbero approfittare anche Al Qaeda e l’Islamic State del Khorasan per rilanciare il jihad globale, e che potrebbe degenerare in una replica amplificata del caos libico, con l’intervento di vari attori esterni.
Allora è bene chiarire subito quali devono essere le iniziative da intraprendere. Primo: aiutare certamente la popolazione per tramite delle Nazioni Unite, la CRI e le Ong riconosciute. Secondo: sostenere finanziariamente il governo, alle sole condizioni di accettare le altre rappresentanze in un governo realmente “inclusivo”, che affermi comunque una sua “centralità” effettiva. Terzo: tutelare i diritti, assicurando tempestivamente un sistema di giustizia che sia imparziale, efficiente ed autorevole. Si potrà pensare anche alla costituzione di una Commissione internazionale per l’accertamento delle discriminazioni basate sulla religione, sulla razza e sul sesso. E se si vuole essere ancora più stringenti, va pensato alla istituzione di un ufficio permanente della Corte penale internazionale, con un mandato esteso alla persecuzione femminile.
In definitiva, ancora una volta va ribadito che è giunto il momento delle scelte.
Foto: Twitter, Emirato Islamico dell’Afghanistan e US DoD