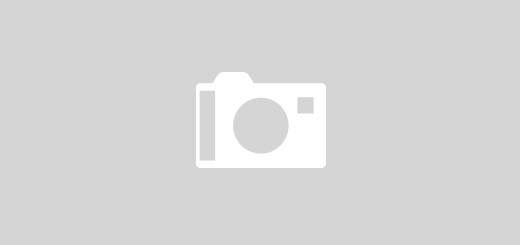Alcune valutazioni sull’uccisione dell’ultimo califfo dello Stato Islamico
Sono diversi gli interrogativi che gli analisti si stanno ponendo sull’eliminazione “dal campo di battaglia” dell’ultimo Califfo dello Stato Islamico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, il successore di al-Baghdadi. L’attacco delle forze speciali è avvenuto in territorio siriano nella zona di Atmeh, nella parte occidentale vicina al confine con la Turchia, costando l’uccisione di 13 persone, tra cui 6 bambini e 4 donne. Le fonti americane hanno tacitato le polemiche sul coinvolgimento delle vittime civili riconducendo le responsabilità al “disperato atto di codardia” di al-Qurayshi, che ha deciso di farsi saltare in aria, anche con alcuni suoi familiari.
Una questione riguarda anche la valutazione sull’intervento e la scelta di ricondurre il livello decisionale alla massima autorità politico-strategica. È infatti lo stesso Biden ad aver dichiarato di avere condiviso e seguito l’azione in diretta nella situation room: “La scorsa notte, sotto la mia direzione, le forze militari statunitensi nel nord-ovest della Siria hanno intrapreso con successo un’operazione antiterrorismo per proteggere il popolo americano e i nostri alleati e rendere il mondo un posto più sicuro”.

Secondo la ricostruzione del New York Times, l’assalto è stato effettuato da 25 militari, supportati da elicotteri da combattimento, e una estesa copertura alle diverse quote di droni armati e jet d’attacco. Gli elicotteri hanno trasferito le unità speciali nell’area dopo la mezzanotte, circondando l’edificio e intimando, con altoparlanti, agli abitanti di arrendersi. Dopo circa due ore, l’azione ha visto una successione di colpi di mitragliatrici, missili ed esplosioni. Sempre Biden ha riferito di avere ordinato al Pentagono di “adottare ogni precauzione possibile per minimizzare il numero delle vittime civili”.
E ha precisato: “Sapendo che questo terrorista aveva scelto di circondarsi dei membri della sua famiglia, compresi bambini, abbiamo scelto di usare un raid delle forzi speciali, con un rischio maggiore per i nostri, piuttosto che un raid aereo”. Al-Qurayshi non avrebbe usato “solo un giubbotto esplosivo, ma ha fatto esplodere l’intero terzo piano, senza nessun riguardo per la vita dei suoi familiari e degli altri che erano nell’edificio”. Ancora Biden ha sottolineato: “Piuttosto che fronteggiare la giustizia per i crimini che aveva compiuto, ha portato con sé i membri della sua famiglia, proprio come aveva fatto il suo predecessore”, riferendosi ad al-Baghdadi che il 27 ottobre 2019 si fece esplodere con i suoi due bambini.
Queste dichiarazioni possono essere lette sotto vari profili. Uno potrebbe evidenziare la volontà di catturare vivo il pericoloso terrorista e di prevedere la sua uccisione solo come extrema ratio a seguito di una reazione armata sua o di suoi fiancheggiatori. Tuttavia, si è constatato che, nei fatti, gli interventi risolutivi con l’inevitabile uccisione del capo militare delle forze avverse fa ormai parte della dottrina della “guerra selettiva” nella lotta al terrorismo islamista che in tutta evidenza gli Stati Uniti hanno adottato: si colpiscono i leader, gli ideologi e gli organizzatori del jihad, anche nella reale impossibilità di colpire tutti i terroristi prima che agiscano.

Gli esempi della frequenza di tale scelta sono diversi. Nel 2006, mentre Saddam Hussein fu condannato all’esecuzione capitale al termine di un processo, in un attacco aereo congiunto delle forze statunitensi e giordane fu ucciso il leader di al-Qaeda in Iraq Musayb al-Zarqāwī.
Il 2 maggio 2011 fu la volta del capo di al-Qaeda, Osama bin Laden, ucciso nel corso dell’operazione condotta dai Navy Seal. Nel 2019, come si è visto, il califfo dell’Isis al-Baghdadi si è sottratto alla cattura delle forze speciali facendosi esplodere con i suoi bambini, e il 2 gennaio 2020 un drone armato ha invece ucciso il potente generale iraniano Qassem Suleimani, ritenuto strenuo oppositore degli Stati Uniti.
L’ultima operazione significativa statunitense è stata condotta durante il ritiro afghano per reazione agli attacchi suicidi all’aeroporto di Kabul del 25 agosto scorso, compiuti dai miliziani dell’Isis del Khorasan (IS-K), che avevano causato 200 vittime tra cui 13 marines. In questo caso gli Stati Uniti hanno reagito con un attacco di droni armati che hanno annientato i “pianificatori” degli attacchi, coinvolgendo tuttavia anche diversi civili.
Il coinvolgimento dei civili in un’operazione antiterrorismo, che abbia i connotati di una operazione bellica o di polizia, è sempre un evento che in astratto può configurare un “crimine di guerra” o “contro l’umanità” anche ai sensi dello Statuto della Corte penale internazionale.
A meno che non si dimostri che l’evento era imprevedibile, o che nella pianificazione e nella condotta delle operazioni erano state poste in essere tutte le necessarie misure organizzative (nell’intelligence, nella scelta dei mezzi e metodi di combattimento, etc.) e di precauzione per evitarlo. La situazione della “necessità militare”, che giustificherebbe “effetti collaterali”, è una ipotesi scriminante ormai molto ridimensionata dall’attuale sensibilità cui è approdato il sistema del diritto internazionale umanitario: è il caso dei bombardamenti o dei lanci di missili per i quali, in ragione dell’avanzato grado tecnologico di individuazione degli obiettivi e dei sistemi d’arma, i tribunali internazionali sono portati tendenzialmente ad incriminare i casi di coinvolgimento di civili, anche se si configura il solo dolo eventuale.

Il procedimento logico che in questi casi un legal advisor militare potrebbe seguire per consigliare il responsabile delle operazioni potrebbe essere il seguente: proprio perché le condizioni necessitanti di una rischiosissima operazione non possono prevederne l’evoluzione, va sempre valutata in sede di pianificazione una opzione diversa da quella dell’assalto diretto all’edificio in cui è localizzato un terrorista.
Può sembrare l’uovo di colombo, ma sul piano pratico c’è un modello operativo che ha consentito di superare condizioni anche più critiche: posto che una irruzione nell’ abitazione di un terrorista può comportare come reazione l’auto-esplosione dello stesso, con il coinvolgimento anche di famiglie inermi delle vicine abitazioni, la scelta operativa che in questi casi si deve tendere a realizzare è la “neutralizzazione in strada”, quando cioè l’obiettivo esce dall’edificio e può essere immobilizzato da operatori infiltrati tra la gente comune. Il terrorista potrebbe avere un giubbotto esplosivo, ma rientrano negli standard operativi delle forze speciali interventi efficaci e tempestivi che consentono di evitare l’attivazione dell’ordigno ed il coinvolgimento di civili.

È tuttavia da considerare che nella valutazione di un intervento incidono tante variabili, fra cui non ultima quella di accelerare l’esecuzione subito dopo la conferma della reale individuazione del soggetto da catturare/neutralizzare, oppure la gravità del contesto emergenziale in cui potrebbe prevedersi un imminente attacco terroristico su vasta scala.
E vanno considerati, ovviamente, tutti i limiti e i condizionamenti di un’azione realizzata in territorio ostile, dove ad esempio l’infiltrazione di operatori può risultare difficoltosa, specie se da realizzare in tempi brevissimi. Come vanno pure valutati la complessità e il livello di pianificazione strategica che riguardano teatri operativi più complessi: non a caso prima dell’operazione sull’area di Atmeh, il Pentagono aveva avvertito Mosca, Ankara e Damasco di sgomberare lo spazio areo al confine tra Siria e Turchia.
In definitiva, il tema si presta a valutazioni di particolare complessità, in cui la sola risposta giuridica non è sufficiente e soprattutto è difficile da calare nella realtà e nelle difficoltà di una scelta “sul campo”. In questo ambito, il comandante operativo ha una responsabilità diretta nel processo decisionale, in cui dovrebbe comunque far ragionare anche la sua “etica del comando”. Ricordando anche un monito di Friedrich Nietzsche: “Attento, quando combatti un mostro, cerca di non diventare un mostro tu stesso”.