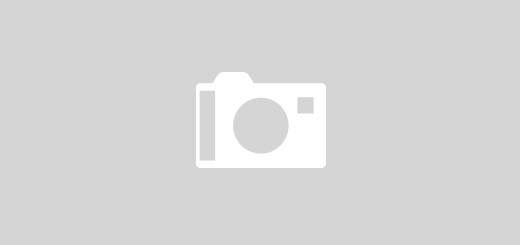Dall’Afghanistan alle banlieues: la “Guerra dei 20 anni” che abbiamo perduto su tutti i fronti
Per sua fortuna Donald Rumsfeld, segretario alla Difesa dell’amministrazione di George W. Bush che scatenò e vinse la guerra-lampo contro i talebani subito dopo gli attacchi dell’11/9, è deceduto il 29 giugno scorso.
Se n’è andato giusto in tempo per non vedere, a quasi 90 anni di età, il triste spettacolo della disordinata ritirata americana e della NATO da Kabul, avvenuta in modo umiliante con il permesso dei talebani, di nuovo padroni dell’Afghanistan.

A Rumsfeld, noto per i suoi metodi ruvidi e politicamente scorretti anche nei confronti dei media, che fu tra gli artefici di Enduring Freedom e della strategia per condurre la “Long War” contro il jihad globale, la morte ha risparmiato anche il patetico spettacolo di vedere il suo successore al Pentagono, il molto politicamente corretto generale Lloyd Austin, celebrare come una vittoria il ponte aereo da Kabul che ha evacuato 150 mila afghani con il via libera dei talebani ma ha sacrificato altri 13 soldati americani offrendo un bersaglio facile al terrorismo targato Stato Islamico.
“Rummy”, come lo chiamava il presidente Bush, aveva previsto che la guerra al terrorismo islamico sarebbe durata 20 anni ma non immaginava certo che gli Stati Uniti e l’intero Occidente l’avrebbero perduta, sul campo di battaglia e sul piano politico e ideologico.
Perché non c’è dubbio che, 20 anni dopo i 3mila morti dell’11 settembre, la guerra tra Occidente e jihad si è conclusa, con la nostra sconfitta, proprio là dove era cominciata: negli USA e in Afghanistan prima ancora che le truppe della NATO completassero il loro ritiro.
A Kabul i talebani sono tornati al potere dopo una folgorante vittoria militare che ha ridicolizzato gli alleati e cancellato governo ed esercito “fantoccio dei crociati”.
Non si può escludere che gli USA puntassero a lasciare a russi e cinesi la “patata bollente” dei talebani e dei gruppi terroristici presenti in Afghanistan e nella regione tribale del Pakistan ma non c’è dubbio che le modalità con cui è caduta Kabul e le atre città afghane ha umiliato gli Stati Uniti, la NATO, l’Europa e le loro rispettive leadership.
A ulteriore umiliazione il nuovo esecutivo talebano vede protagonisti uomini che ebbero già ruolo di rilievo nel loro precedente governo o durante la guerra agli infedeli, quasi a voler mostrare con orgoglio una classe dirigente composta da leader ritenuti “terroristi” in Occidente e sui quali in alcuni casi gli USA hanno posto taglie consistenti.
Venti anni or sono la guerra prese il via perché i talebani si rifiutarono di consegnare Osama bin Laden a Washington ma si conclude oggi con i talebani di nuovo alla guida dell’Afghanistan che celebrano la ricorrenza nel palazzo presidenziale di Kabul con i terroristi di al-Qaeda ancora ben presenti in Afghanistan, nonostante gli impegni assunti negli accordi di Doha con gli Stati Uniti.

“Vae victis” potrebbe simbolicamente esclamare oggi Yaqub, figlio del Mullah Omar che secondo la mitologia talebana sfuggì 20 anni or sono agli americani passando il confine pakistano in sella a una motocicletta.
A Washington i 20 anni da quel giorno del 2001 verranno celebrati non senza polemiche da un’America sconfitta, fuggita da un Afghanistan per l’incapacità di sostenere nel tempo uno sforzo tutt’altro che insostenibile per una super-potenza.
Certo, USA e NATO continuano a celebrare come un successo l’evacuazione da Kabul di 150 mila afghani di fatto raccontando che la fuga è stato un trionfo ma si tratta solo di un irritante tentativo di mascherare la disfatta pur di non doverne trarre le amare lezioni.
Un patetico escamotage che non cambia la realtà sotto gli occhi di tutti: l’Occidente ha perso la “Guerra dei 20 anni” contro il jihadismo non per incapacità militare ma per insipienza politica, per la totale assenza di obiettivi strategici da perseguire con continuità nel tempo, per l’ambigua gestione di una guerra per combattere la quale abbiano tutti perso le motivazioni e per l’incapacità strutturale delle società occidentali di accettarne i costi in termini di morti e feriti: poco più di 3.600 caduti in 20 anni dei quali 2.465 statunitensi, 455 britannici e gli altri appartenenti ad altre 30 nazioni.

Perdite spalmate su due decenni, che includono anche i morti per incidenti e suicidio, che un tempo sarebbero state definite ininfluenti ma che risultano oggi insostenibili per le svirilizzate società occidentali.
Non basta spendere miliardi per disporre di tecnologie belliche sofisticate e di una potenza senza precedenti se non si hanno valori, principi e interessi per i quali si ritenga necessario combattere e accettare di subire perdite.
L’assenza di questa capacità ha quindi reso privi di significato i morti nelle guerre di questi 20 anni.
Sul piano politico, tra i tentativi di trarre lezioni accomodanti, sono in molti a ripetere che non si può esportare la democrazia con le armi anche se la Storia dice il contrario.
Soprattutto in Italia, Germania e Giappone la democrazia è stata portata a suon di bombardamenti, sbarchi, invasioni e persino bombe nucleari.
Dopo 75 anni però gli Stati Uniti sono ancora presenti in queste nazioni, con basi militari e con un‘influenza politica, economica e “spionistica” che spesso è apparsa fin troppo irritante e invadente nei confronti di stati sovrani amici degli USA.
L’errore in Afghanistan e in Iraq è stato non tanto quello di pretendere di portarvi la democrazia con le armi, in base alle dottrine neocon che vedevano nella libertà l’antidoto contro il terrorismo islamico, ma la supponenza di poter poi riportare a casa le truppe dopo pochi anni.

Se George W. Bush ha scatenato operazioni ambiziose come Enduring Freedom e Iraqi Freedom, Barack Obama ha abbandonato l’Iraq nel 2011 (lasciandolo infatti alla mercè dello Stato Islamico piombato nel 2014 sulle regioni occidentali e settentrionali) e avviato il disimpegno dall’Afghanistan dieci anni or sono, subito dopo l’uccisione di Osama bin Laden, dopo averlo però annunciato colpevolmente nel 2010 incoraggiando così i talebani a resistere e attendere.
Sempre Obama ha avviato i negoziati con i talebani conclusi da Donald Trump che pose condizioni agli insorti ma poi, nell’imminenza del voto, ridusse a tal punto gli effettivi militari a Kabul da indurre i talebani (e i pakistani lorio sponsor) a maturare la convinzione che gli americani volessero andarsene, “senza se e senza ma”, ad ogni costo.
Convinzione ampiamente confermata dall’Amministrazione di Joe Biden, copertosi di ridicolo ma che senza dubbio ha pagato il conto anche per gli errori dei suoi predecessori anche se, va ricordato, l’attuale presidente americano è stato il vice di Barack Obama.
Di certo in questi 20 anni il mutevole atteggiamento della politica americana ha da un lato confuso gli alleati, colpevoli però di non aver mai neppure tentato di elaborare proprie strategie mostrando così una perfetta attitudine ad essere gregari ma non protagonisti.
Dall’altro ha incoraggiato i nemici col risultato che oggi tutti i movimenti jihadisti escono galvanizzati dal trionfo talebano.

L’ambiguità di Washington ha raggiunto il picco durante gli otto anni di Amministrazione Obama con il sostegno all’estremismo islamico della Fratellanza Musulmana, evidente nelle cosiddette primavere arabe che hanno visto cadere i regimi tunisino ed egiziano e hanno indotto le monarchie sunnite e in genere il mondo arabo a diffidare degli USA.
Per non parlare del sostegno militare e politico alle “rivoluzioni” in Libia e Siria: nella prima è stato destabilizzato il Mediterraneo Centrale alle porte dell’Italia e nella seconda sono stati apertamente armati dalle potenze occidentali movimenti e milizie jihadiste che si richiamano alla stessa ideologia dei terroristi che hanno compiuto stragi in Europa e Stati Uniti.
Una dottrina confusa e una strategia destabilizzante che ha avuto come principale obiettivo il rinnovo di un confronto sempre più acceso con la Russia, nazione che avrebbe invece tutte le carte in regola per essere un partner e un alleato nella guerra ai jihadisti e che invece Washington vuole poter dipingere ancora come “nemico”, complice un’Europa prona e imbelle.
Un’Europa anche oggi talmente incapace di affrontare con realismo e pragmatismo la disfatta subita in Afghanistan da limitarsi a emettere la solita cortina fumogena rappresentata dall’annoso sterile dibattito sulla necessità di un “esercito europeo”.
Le severe lezioni inferte dalla sconfitta dell’Occidente nella guerra al jihad insegnano ciò che dovevamo già sapere almeno dai tempi della partecipazione alla guerra in Somalia, tra il 1992 e il 1994.
Non si può cominciare un conflitto senza avere ben chiari gli obiettivi da raggiungere e senza avere la determinazione a continuare a combatterlo, ad ogni costo, fino alla vittoria.
Al tempo stesso abbiamo crescenti difficoltà ad affrontare un conflitto lungo e asimmetrico che vede le nostre città vulnerabili al terrorismo, con alle spalle società così fragili da essere ormai incapaci di soffrire (ma quale resilienza?) come quelle occidentali.
Nazioni guidate da leader in buona parte all’altezza di dirigere forse banche e Ong ma tra i quali si intravedono ben pochi statisti.
Anche per questo la cocente sconfitta di Kabul aumenta il rischio di nuovi attacchi terroristici contro USA ed Europa e del resto giova ricordare che una delle ragioni a lungo esposte per giustificare la nostra presenza militare in Afghanistan era quella di impegnare lontano da casa nostra le forze jihadiste.
Al termine di 20 anni di guerra l’Occidente rischia quindi di venire percepito nel mondo come inaffidabile, debole e imbelle divenendo così anche più esposto e vulnerabile.

La nostra sconfitta emerge infatti anche dalla crescente disponibilità dei governi occidentali a relativizzare i nostri valori, ad accettare l’immigrazione islamica regolare e clandestina come ineluttabile e a tollerare nelle nostre città che un crescente numero di “no go area” vengano arbitrariamente governate dalla sharia e dove la polizia, talvolta neppure i vigili del fuoco, possono entrare senza venire attaccati da milizie paramilitari islamiche armate (per ora) di mortaretti e fuochi d’artificio.
Le nazioni occidentali fuggite come conigli dall’Afghanistan protestano perché in Afghanistan torna il burqa e la discriminazione femminile (che in realtà non erano mai scomparsi in questi 20 anni) e non si accorgono che molti quartieri delle città d’Europa non sono così poi diverse da Kabul in termini di soppressione dei diritti delle donne.
E’ quindi evidente che la “guerra dei 20 anni” l’abbiamo persa su tutti i fronti: non solo in Afghanistan e nelle periferie delle nostre città ma anche lungo i nostri confini, attraversabili da chiunque (per lo più islamici) paghi criminali per venire in Europa da cui difficilmente verrà espulso anche se compie atti illegali.
Se volessimo riprendere il concetto di “scontro tra civiltà”, tanto dibattuto proprio 20 anni or sono all’indomani dell’11/9, dovremmo ammettere di averlo oggi perduto, ponendoci l’obiettivo di vincerlo domani. Ed è forse anche per questo che non se parla più.