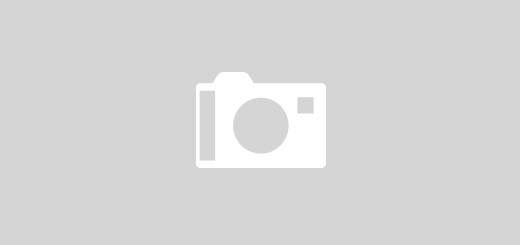La miopia dell’impegno internazionale in Afghanistan
Il ritiro dall’Afghanistan a seguito degli Accordi di Doha (29 febbraio 2020), confermato dalla recente decisione del Presidente Biden, in un momento in cui gli insorti estendono rapidamente il controllo su di una parte sempre più vasta del territorio, ha già dato luogo a intensi dibattiti su “chi ha perso l’Afghanistan?”, malgrado il Paese non sia ancora “perduto”.
È un evento epocale che si presta (e si presterà) nei prossimi mesi e anni ad ampie analisi e discussioni, come avvenuto dopo la caduta di Saigon (1975), per motivare o capire questo fallimento, con uno strascico di recriminazioni e accuse su chi sia (stato) il responsabile di aver abbandonato l’Afghanistan al proprio destino.

Le motivazioni possono essere tante, ma sono sostanzialmente riconducibili al non aver tenuto conto delle precedenti esperienze occidentali in materia di contro-insurrezione (counterinsurgency – COIN).
Le COIN sono caratterizzate da alcuni aspetti fondamentali che mantengono sempre, con gli opportuni adeguamenti dovuti ai tempi, piena validità concettuale: cambiano le procedure d’azione ma i principi guida rimangono sostanzialmente gli stessi.
Essi riguardano la natura essenzialmente politica del confronto, una direzione civile-militare unificata, una risposta non limitata esclusivamente all’uso della forza, il ruolo centrale della popolazione, la necessità di un cambiamento dell’organizzazione delle forze impegnate, soprattutto della loro mentalità per adattarla a quella dell’avversario, e l’importanza di sfruttare appieno le potenzialità offerte dai propri equipaggiamenti.
Oltre a questi aspetti, permangono pienamente valide alcune modalità operative quali un rapporto numerico fra forze regolari e insorti assai elevato, l’uso di reparti permanentemente stanziati nella stessa zona, come forma di controllo del territorio, di unità mobili per esercitare una pressione costante sugli insorti e ingenerare in loro un sentimento d’insicurezza.

A tali modalità, deve essere aggiunta la necessità di un capillare controllo delle frontiere. Qualsiasi movimento di guerriglia, infatti, per avere possibilità di successo deve disporre di luoghi d’impunità (i cosiddetti “santuari”), di norma situati all’esterno del Paese interessato all’insorgenza, dove ripiegare, recuperare le proprie capacità e riorganizzarsi sotto la protezione o il tacito consenso della Nazione ospitante.
Sono tutti aspetti ripresi nella pubblicazione US Army FM 3 – 24/MCW 3-33.5 “Counterinsurgency” (December 2006), conosciuta come la “dottrina Petraeus”, che rielabora sostanzialmente le esperienze francesi in Indocina (1945-1954) e in Algeria (1954-1962), da quelle britanniche in Malesia (1947-1960) e statunitensi nelle Filippine (1899-1902) e in Centro-Sud America. Lo stesso termine inglese insurgency trova le sue origini nella storia (dal latino insurgere, ovvero alzarsi, sollevarsi).
Quello che è mutato in modo significativo è, invece, il contesto nel quale le COIN hanno luogo.

Intervenire in un Paese straniero per assistere un alleato minacciato da una insurrezione o per imporre un nuovo regime, come in Iraq, in Afghanistan o nel Sahel, costituisce uno sforzo diverso dall’effettuare operazioni di polizia coloniale e/o reprimere la guerriglia dei movimenti di liberazione, considerati interventi “interni” nell’ambito di un impero coloniale.
Oggi le COIN sono condotte di norma da una coalizione, a seguito di una risoluzione dell’ONU, in supporto ad uno Stato sovrano con un governo spesso troppo debole, che risulta incapace o riluttante nel condurre le operazioni o nell’accettare le misure consigliate.
Negli scenari contemporanei il successo richiede uno sforzo pienamente integrato, i cui guadagni in termini di sicurezza siano immediatamente seguiti da guadagni politici, economici e umanitari finalizzati a migliorare le condizioni di vita della popolazione, affinché tolga il suo appoggio agli insorti.

Come ha sottolineato l’ufficiale francese Roger Trinquier (1908-1986), sostenitore della guerra rivoluzionaria appresa combattendo in Indocina, la condizione sine qua non per il successo contro un’insorgenza è il supporto incondizionato della popolazione, che permetta di coinvolgerla in un processo di collaborazione per isolare e sconfiggere l’avversario; una delle variabili chiave che non è stata conseguita in Afghanistan.
In secondo luogo, si è passati da una configurazione “bidimensionale” delle situazioni conflittuali (governo nazionale/coloniale contro gli insorti) a una “tridimensionale”, nella quale gli insorti si confrontano non solo con il governo locale, ma con una variegata compagine di “attori” quali le forze multinazionali, le organizzazioni internazionali (ONU, EU, ecc.), le agenzie governative e non governative, le rappresentanze diplomatiche e i media, ognuno dei quali con proprie priorità, interessi “di settore” e visione soggettiva della crisi. A questi occorre aggiungere un “quarto attore” rappresentato dai Paesi che più o meno palesemente sostengono gli insorti.

In Afghanistan è mancato sin dall’inizio un indirizzo unitario nella condotta dell’intervento: in questi ultimi vent’anni si sono succedute quattro missioni con finalità, regole d’ingaggio e modus operandi diversi.
La International Security Assistance Force (ISAF), dal 20 dicembre 2001 al 31 dicembre 2014, e la Resolute Support Mission (RSM), dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2021, entrambe a seguito di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e rivolte, oltre che a contrastare l’insurrezione talebana, a stabilizzare il Paese e a contribuire allo sviluppo socio-economico della società affinché il governo afghano potesse esercitare la propria piena sovranità.
Le Operazioni a guida statunitense Enduring Freedom (OEF), dal 7 ottobre 2001 al 28 dicembre 2014, e Freedom’s Sentinel (OFS), dal 29 dicembre 2014 ad oggi, indirizzate esclusivamente a combattere il terrorismo.
La mancanza di una exit st rategy condivisa dopo la deposizione del regime talebano e il successivo insediamento di un governo provvisorio, a seguito degli accordi di Bonn (dicembre 2001), non ha consentito di definire l’End State da conseguire al termine dell’impegno internazionale, da cui doveva discendere una coerente strategia e le risorse necessarie per la condotta delle operazioni.
rategy condivisa dopo la deposizione del regime talebano e il successivo insediamento di un governo provvisorio, a seguito degli accordi di Bonn (dicembre 2001), non ha consentito di definire l’End State da conseguire al termine dell’impegno internazionale, da cui doveva discendere una coerente strategia e le risorse necessarie per la condotta delle operazioni.
ISAF, in particolare, una delle più grandi, lunghe e impegnative missioni della storia, che al suo apice (2011) consisteva in oltre 130.000 uomini e donne provenienti da 51 Nazioni della NATO e dei Paesi partner, era – di fatto – una “coalizione di più coalizioni”, incentrata sulle nazioni leader (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Turchia, USA) responsabili delle operazioni nelle cinque regioni in cui era suddiviso il Teatro Operativo.
Una parte di questi Paesi ha partecipato alla missione in qualità di membro della NATO, un’altra parte perché è stato loro chiesto e un’altra ancora per “onorare debiti morali” o guadagnare “crediti” nelle relazioni internazionali: un approccio molto simile al “gioco europeo delle alleanze” del XVIII e del XIX secolo.

Questo ha determinato una partecipazione non sempre (o quasi mai) sinergica, dovuta ai prioritari interessi nazionali, a una differente (prudente) interpretazione nell’uso della forza, alla rispettiva cultura nazionale (es., diverso valore attribuito alla vita umana), ai caveat e agli indirizzi dei rispettivi governi che hanno impedito di condurre la campagna militare in modo accentrato.
I caveat, in particolare, quali vincoli che discendono dalla volontà politica nazionale, hanno condizionato le capacità esprimibili dai contingenti nell’affrontare gli insorti con evidenti disparità di risultati e di controllo del territorio (nazioni europee di primo piano avevano decine di caveat che, di fatto, confinavano le loro consistenti forze all’interno delle accoglienti basi).
I contingenti occidentali, inoltre, non hanno potuto utilizzare appieno le capacità dei mezzi a disposizione in quanto limitati dalle direttive politiche, spesso frutto di motivazioni ideologiche o dal timore di fornire alla opinione pubblica nazionale un’immagine troppo aggressiva della propria presenza.
Un atteggiamento che ha portato a coniare la frase “NATO: Not Action Talk Only”.

Seguendo le regole prevalenti del politicamente corretto, governanti e società civile occidentale hanno fatto sempre più ricorso a eufemismi tesi ad ammorbidire la spiacevole realtà della guerra. Il nemico non si uccide: si neutralizza; le vittime civili diventano un danno collaterale. Spesso mutuate dall’inglese, definizioni che sottintendono varie forme di operazioni, come peacekeeping, peace-enforcement o nation-building, perdono apparentemente aggressività e divengono ben accette agli occhi del pubblico civile e dei mass media.
Ed ecco, dunque, elicotteri per l’evacuazione sanitaria che non potevano volare di notte, seppur attrezzati, velivoli da combattimento che non potevano condurre azioni di supporto di fuoco alle unità a terra e limitavano i loro compiti alla sola ricognizione aerea e/o alla distruzione delle antenne per le comunicazioni dei Talebani, mentre l’uso delle armi di bordo era autorizzato esclusivamente per autodifesa (i Talebani avevano per caso un’aeronautica?).

Ciò comportava di dover richiedere il supporto aereo ad altri contingenti che non avevano questi (piuttosto ipocriti) condizionamenti, con il rischio di non ottenere in tempo il concorso e subire perdite che altrimenti non si sarebbero verificate (oltre a maturare una pessima reputazione in ambito coalizione).
Non sempre, inoltre, hanno funzionato i metodi impiegati nella ricostruzione del Paese (nation building) in quanto chi è intervenuto riteneva di sapere meglio della popolazione cosa servisse loro in termini di governance e modelli socio-economici.
Non basta aver letto “Il Cacciatore di Aquiloni” (Kite Runner) sull’aereo per poter presuntivamente credere di essere un esperto dell’Afghanistan!

La convinzione – anche ispirata dalle migliori intenzioni – che l’introduzione più o meno forzata di riforme democratiche potesse proteggere la popolazione, vincere “i cuori e le menti” e sconfiggere l’insorgenza è stata percepita come un’imposizione di un sistema estraneo alla cultura afghana e distante dalla sua realtà.
Cercare di promuovere dall’esterno la democratizzazione, ignorando che non bastano le istituzioni democratiche per “generare” democrazia in culture che, qualunque siano i loro meriti, non hanno una società civile di modello occidentale, ha provocato in passato la caduta di alleati fidati, come lo Shah dell’Iran o il Presidente del Vietnam del Sud Ngo Dinh Diem, ed ha agevolato l’instaurazione di regimi ostili e ancora più autoritari.
È questo il risultato di un approccio etnocentrico, che privilegia i valori della cultura occidentale per analizzare le altre culture, in particolare le più lontane, e che considera tali valori come universali.

Il confronto, invece, è incentrato sulla ricerca della legittimazione: la “ricetta” per ottenere il consenso si basa prevalentemente sulla percezione soggettiva della popolazione, e non su elementi oggettivi come la democrazia o lo stato di diritto, la quale deve essere coinvolta come “attore chiave” nel processo di cambiamento piuttosto che come un “soggetto terzo” o un “premio da vincere” attraverso le attività di conquista “dei cuori e delle menti”.
Lo storico militare Max Boot nel suo libro Invisible Armies An Epic History of Guerilla Warfare from Ancient Times to the Present (2013), che ripercorre in modo approfondito e dettagliato la storia della guerriglia dalle origini ai giorni nostri, ha evidenziato che le population-centric counterinsurgency (più conosciute come winning hearts and minds) hanno avuto un essenziale ruolo nell’ottenere il successo nelle campagne di contro-insurrezione.

I vertici politici e diplomatici delle missioni, sia per limiti conoscitivi sia per la difficoltà di interagire con l’elemento locale, o per buona fede, hanno teso ad appoggiarsi alle élite economiche e intellettuali di formazione cosmopolita maggiormente propense a sposare modelli occidentali, trascurando la circostanza di non poco conto che una élite non è rappresentativa della società.
Occorre, invece, conoscere il territorio, la cultura e la storia, gli usi e costumi del Paese, capire cosa intendono le popolazioni quando chiedono maggiore sicurezza: potrebbe significare solo “poter andare al pozzo per prendere l’acqua, mandare i figli a scuola, poter essere curati, ecc.”.
Ciò richiede forze di sicurezza locali con una forte motivazione per la causa e pieno riconoscimento da parte della propria società, ma anche un esteso impegno civile per stabilire un nuovo sistema di governance, di giustizia e di gestione socio-economica, che deve includere anche il reclutamento e la formazione dei dipendenti pubblici.

Non sempre è stato possibile disporre di individui con un buon livello culturale, in quanto le organizzazioni governative e non governative straniere hanno reclutano la maggioranza delle persone che conoscevano le lingue straniere, con retribuzioni decisamente superiori a quelle di un dipendente pubblico. Di conseguenza a lavorare nella pubblica amministrazione rimanevano (e rimangono) spesso i meno qualificati.
La corruzione è il problema principale dell’Afghanistan in quanto, inficiando la fiducia della popolazione nell’apparato istituzionale, ne mette a rischio la sua stabilità.
Il contrasto a tali condotte illecite non ha mai ottenuto i risultati desiderati, malgrado gli ultimi governi afghani abbiano cercato di arginare il fenomeno che rappresenta un malcostume endemico in tutti gli strati della società: un “modello relazionale” non percepito, sino ad un certo limite, come un aspetto negativo da osteggiare.

Un problema dovuto anche alla Comunità Internazionale che non sempre ha controllato (o inteso controllare) la destinazione, la gestione e l’impiego dei fondi e la distribuzione degli aiuti (situazione purtroppo ricorrente in tale tipologia di missioni).
Uno dei principali ostacoli alla sconfitta dei Talebani è stata sia l’instabilità del governo afghano, e la sua incapacità di elaborare pianificazioni efficaci e preventive per contrastare l’azione avversaria, sia il mancato rafforzamento strutturale delle forze di sicurezza in previsione del ripiegamento dei contingenti NATO (pre-posizionamento munizioni, riorganizzazione dei presidi, ridislocazione delle unità, ecc.).

Le Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) hanno combattuto con bravura e spirito di sacrificio, almeno sino a quando sono state affiancate dalle forze multinazionali, con tassi di perdite simili a quelli statunitensi nei momenti di maggior impegno in Vietnam.
Il repentino ritiro dei contingenti stranieri, in piena fighting season estiva, ha chiaramente rimarcato le (note) lacune capacitive e le difficoltà che impediscono alle ANSDF di contenere autonomamente l’offensiva talebana, come hanno già evidenziato sia in passato sia recentemente diversi Generali statunitensi che hanno guidato le operazioni nel Paese, tra cui Stan McChrystal, David Petraeus, Joseph Dunford e ora Mark Milley, l’attuale Chairman of the Joint Chiefs of Staff.
Tali difficoltà sono anche dovute alla presunzione di aver voluto addestrare le ANSDF secondo i canoni occidentali, senza tener conto che per formare una Forza Armata dalla struttura convenzionale servono anni e una solida e professionale classe di comandanti, soprattutto quando la cultura è completamente diversa, come si era già visto con le Forze Armate irakene.

Le forze di sicurezza afghane, poi, sono composte da personale con differenti background: i mujaheddin della lotta antisovietica, i militari del passato regime comunista e i più giovani formatisi alle scuole NATO, pakistane e indiane. Un insieme di mentalità e di diversa formazione che non sempre si raccordano tra di loro e che hanno spesso generato incomprensioni a livello d’impiego.
A tutto ciò concorre anche l’analfabetismo che amplia i problemi sopra citati. Quarant’anni di conflitti hanno condizionato il sistema scolastico e i grandi progressi compiuti negli ultimi anni, che hanno sicuramente ridotto l’entità del fenomeno, ma non lo hanno ancora risolto.
Sarebbe stato sicuramente più redditizio potenziare le loro innate doti combattive di guerrieri più temibili dell’Asia Centrale; del resto i Talebani, anche loro Afghani, combattono secondo questi tradizionali schemi.

Il Generale russo Makhmut Garayev (1923 – 2019), ultimo consigliere militare del Presidente Najibullah della Repubblica Democratica dell’Afghanistan (1989 – 1991), ha affermato: bisogna prendere gli Afghani per quello che sono e non come noi vorremmo che fossero.
Il ritiro dall’Afghanistan nelle condizioni previste dall’accordo di Doha appare una sconfitta di tutta la Comunità Internazionale e di ogni Nazione che ha partecipato alla missione.
L’invio dei contingenti militari richiede un disegno politico ampio e condiviso e la definizione di obiettivi realistici, che in questo caso non sempre sono stati definiti a causa della prevalenza degli interessi e delle priorità nazionali, quasi sempre subordinati agli imperativi del pragmatismo politico.

Nel dicembre 2009, il Presidente Barak Obama su pressante richiesta del generale McChrystal (comandante della missione ISAF) e del generale Petraeus (comandante del Comando Centrale statunitense responsabile per il Medio Oriente) autorizzò un surge di 30.000 uomini a partire dall’inizio 2010 che, unitamente ai 21.000 immessi ad inizio 2009, permise di ottenere incoraggianti progressi nel contrastare i Talebani.
Nella stessa circostanza il Presidente Obama, a discapito di ogni logica strategica, affermò che l’incremento di forze sarebbe stato a tempo determinato e limitato a un periodo di 18 mesi (luglio 2011) per poi passare gradualmente ad una missione di assistenza militare sino a fine 2014 (termine missione ISAF): una contraddizione che ha vanificato lo stesso sforzo americano e alleato.
Una decisione presa per le crescenti difficoltà interne (crisi economica, debito pubblico, opposizione al conflitto nell’opinione pubblica americana) che doveva prevedere l’inizio del ritiro in tempo per la campagna presidenziale del 2012; la stessa scelta ripetutasi nel 2020 con il Presidente Trump.

Per i Talebani è stato sufficiente attendere la fine della missione ISAF per poter riprendere l’iniziativa.
È come se il Presidente Roosevelt avesse dichiarato che le forze alleate si sarebbero ritirate dal Teatro europeo dopo lo sbarco in Normandia (giugno 1944).
Gli sforzi, per diventare progressi strategici, devono accompagnarsi a successi duraturi; solo in questo caso è possibile invertire il corso della “guerra” traendo vantaggi dal deterioramento della coesione degli insorti provocata dal surge. L’esperienza storica insegna che la pacificazione di un Paese o di una regione comporta tempi lunghi (almeno 2-3 generazioni) e misure finalizzate.
Si possono effettuare grandi operazioni, disporre di efficienti forze di sicurezza, realizzare un’eccellente cooperazione civile-militare, ma se manca il senso politico della guerra, i militari saranno sempre impegnati nelle stesse valli, negli stessi polverosi villaggi e negli stessi deserti rocciosi!
Il territorio tra Pakistan e Afghanistan, come durante l’occupazione sovietica, è stato continuamente attraversato dagli insorti che proprio nell’ex possedimento del Raj hanno avuto i santuari più sicuri.

Alla mancanza di truppe e mezzi sufficienti per presidiare in maniera completa una frontiera così estesa e impervia di oltre 2.500 km, non fatto seguito un’azione diplomatica congiunta (per interessi di parte) al fine di bloccare, o quanto meno limitare, questa “concessione” da parte del Pakistan.
È appena il caso di sottolineare che il controllo delle frontiere è la manifestazione della volontà di uno Stato di affermare la propria sovranità sul territorio nazionale.
Le COIN trovano un senso solo in un più ampio contesto che riesca a elaborare valide alternative all’insorgenza. Non si tratta – se non in minima parte – di un problema militare: la sfida posta dagli insurgent è soprattutto una sfida alle capacità del governo locale di amministrare la popolazione – il centro di gravità del confronto – come è ben definito dal termine hearts and minds.
L’avversario è l’ostacolo, non l’obiettivo!
Il mio pensiero si rivolge ai fratelli afghani, e soprattutto alla parte più debole della società, ovvero alle donne e alle bambine nel timore – sempre più fondato – che ritornino a vivere in condizioni di estrema emarginazione sociale e culturale. Ciò renderebbe vano l’impegno di tanti soldati e civili della Comunità Internazionale che hanno sacrificato la loro vita, tra cui 53 Caduti e oltre 700 feriti e mutilati italiani, per evitare che l’Afghanistan ritornasse ai tempi bui del regime talebano.
Foto US DoD., UK MoD, Difesa.it, ISAF e NATO/Operation Resolute Support