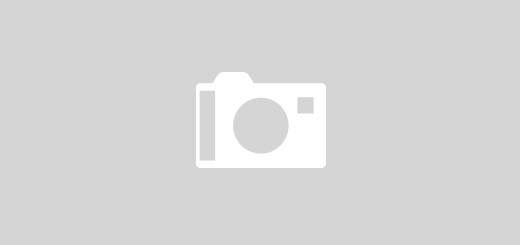La Seconda battaglia difensiva del Don: anatomia di una catastrofe militare
Undici dicembre 1942. Sul medio corso del Don, dove il termometro segna già trenta gradi sotto zero, le prime granate sovietiche iniziano a cadere sulle posizioni della Ravenna e della Cosseria. Nessuno, in quelle ore, può ancora immaginare che sta per cominciare una delle più grandi tragedie militari della storia italiana. Cinquanta giorni dopo, l’8ª Armata avrà cessato di esistere come forza combattente.
Contesto strategico
Per capire cosa successe sul Don bisogna fare un passo indietro. Nell’estate del ’42, mentre la Wehrmacht puntava su Stalingrado e i pozzi petroliferi del Caucaso, agli italiani toccò il compito meno glorioso: presidiare il fianco sinistro del Gruppo d’armate B, lungo il corso del fiume. Duecentosettanta chilometri di fronte, una linea impossibile da tenere con le forze disponibili. Ma Roma e Berlino avevano altre priorità.
L’ARMIR, al comando del generale Italo Gariboldi, schierava sulla carta circa 230.000 uomini: il II Corpo d’armata con le divisioni Cosseria e Ravenna, il XXXV con Pasubio e Torino, il XXIX con Sforzesca e Celere, e il Corpo d’armata alpino con Tridentina, Julia, Cuneense e Vicenza. Numeri ragguardevoli. Peccato che dietro quei numeri ci fossero carenze che avrebbero fatto la differenza tra la vita e la morte.
Debolezze dell’ARMIR
Il vero problema stava nell’equipaggiamento. I cannoni anticarro italiani erano inadatti a fermare i T-34 sovietici, lo sapevano tutti, dai generali all’ultimo fante. Gli automezzi scarseggiavano, rendendo impossibile qualsiasi manovra rapida su un fronte così esteso. E poi c’era il freddo: cappotti leggeri, scarponi che si sfaldavano nel gelo, guanti insufficienti. A quaranta sotto zero, questi dettagli diventano questione di sopravvivenza.
Qualcuno aveva provato a lanciare l’allarme. Il generale Nasci, comandante degli alpini, e altri ufficiali avevano scritto rapporti preoccupati. Il generale Ricagno si era spinto fino a inviare una lettera direttamente a Mussolini. Gay, che comandava la Sforzesca, aveva insistito troppo e si era ritrovato silurato. Le gerarchie non gradivano i cassandri.
A complicare tutto, nelle settimane precedenti l’offensiva sovietica i tedeschi avevano cominciato a sfilare via le unità di rinforzo. La 22ª Divisione corazzata, con i suoi duecento carri, era stata spostata altrove. Poi era toccato alla 294ª e alla 62ª fanteria. Servivano a Stalingrado, dove la situazione precipitava. L’ARMIR restò senza riserve proprio quando ne avrebbe avuto più bisogno.
Operazione Piccolo Saturno

Il piano sovietico, denominato Operazione Piccolo Saturno, rappresentava la seconda fase dell’offensiva generale invernale dopo il successo dell’Operazione Urano che aveva portato all’accerchiamento della 6ª Armata tedesca a Stalingrado. L’obiettivo era sfondare il fronte tenuto dalle forze dell’Asse sul medio Don, allontanare ulteriormente qualsiasi possibilità di soccorso alle truppe di Paulus intrappolate nella sacca, e possibilmente distruggere le armate alleate dei tedeschi.
L’Armata Rossa schierò forze preponderanti: la superiorità numerica era nell’ordine di sei a uno, mentre quella nei mezzi corazzati risultava schiacciante. Dal punto di vista tattico, i sovietici avevano perfezionato la dottrina delle operazioni in profondità, impiegando formazioni corazzate e meccanizzate per penetrare nelle retrovie nemiche e creare sacche di accerchiamento.
La battaglia: prima fase (11-16 dicembre)

L’offensiva ebbe inizio l’11 dicembre con attacchi di logoramento contro il II Corpo d’armata e la divisione Pasubio del XXXV Corpo. Le divisioni Ravenna e Cosseria, insieme ad aliquote della 385ª Divisione tedesca, sostennero il primo urto. Per cinque giorni i reparti italiani resistettero tenacemente, cedendo terreno metro per metro ma mantenendo una parvenza di linea difensiva.
Il 16 dicembre l’Armata Rossa sferrò l’attacco principale. Le colonne corazzate sovietiche penetrarono in profondità nel settore del II Corpo d’armata, sfondando definitivamente il fronte italiano. Contemporaneamente, a sud, la 3ª Armata rumena subiva un analogo destino. In poche ore, la situazione precipitò: l’ala destra dell’ARMIR (XXXV e XXIX Corpo d’armata) si trovò accerchiata e costretta a un ripiegamento in condizioni disperate.
La conca di Arbuzovka: la “valle della morte”

Tra il 21 e il 25 dicembre 1942 si consumò uno degli episodi più tragici della campagna: la battaglia di Arbuzovka. Le colonne italiane in ritirata, composte principalmente dalle divisioni Torino, Pasubio e Celere, oltre a reparti tedeschi della 298ª Divisione, confluirono nella zona di Arbuzovka-Alekseevo Lozovskoe dove, secondo gli irrealistici ordini del Gruppo d’armate B, avrebbero dovuto costituire una nuova linea difensiva.
La 35ª Divisione fucilieri della Guardia sovietica, una formazione veterana che si era distinta nei combattimenti a Stalingrado, chiuse la trappola. Per quattro giorni, circa 30.000 soldati italo-tedeschi tentarono disperatamente di sfuggire all’accerchiamento. Alcuni reparti, tra cui militi della Legione Camicie Nere “3 gennaio”, organizzarono posizioni difensive circolari e si batterono con estremo valore, ma la sproporzione delle forze era troppo grande.
Il bilancio fu catastrofico: tre divisioni italiane vennero sostanzialmente distrutte. La conca di Arbuzovka entrò nella memoria dei superstiti come la “valle della morte”, simbolo di una tragedia che stava assumendo proporzioni apocalittiche.
La seconda fase: l’Operazione Ostrogorzk-Rossoš
Dopo una relativa pausa operativa tra il 22 dicembre e l’8 gennaio, durante la quale il comando dell’8ª Armata tentò di riorganizzare una linea difensiva arretrata, il 12 gennaio 1943 i sovietici lanciarono una nuova offensiva. L’Operazione Ostrogorzk-Rossoš colpì questa volta il Corpo d’armata alpino e il XXIV Corpo d’armata tedesco, fino ad allora rimasti relativamente integri.
La 2ª Armata ungherese, schierata a nord degli alpini, venne travolta il 16 gennaio, esponendo il fianco settentrionale del dispositivo italiano. Il giorno successivo le forze sovietiche investirono i resti delle fanterie italiane, puntando su Rovenki e sulla città di Rossoš, sede del comando del generale Nasci.
L’ordine di ripiegamento dal Don raggiunse il Corpo d’armata alpino solo il 17 gennaio, con un ritardo che si sarebbe rivelato fatale. Le divisioni Julia, Cuneense, Tridentina e Vicenza si trovarono chiuse in una sacca che si stringeva inesorabilmente.
La ritirata: quindici giorni di calvario
Cominciò quello che Mario Rigoni Stern avrebbe raccontato ne “Il sergente nella neve”, una marcia che chi l’ha vissuta non ha mai potuto dimenticare. Duecento chilometri nella steppa ghiacciata, a quaranta sotto zero, senza mangiare, attaccati di continuo dai sovietici e dai partigiani. I feriti venivano caricati sulle slitte finché ce n’erano; poi restavano nella neve.
I congelamenti raggiunsero proporzioni spaventose: trentamila uomini persero dita, mani, piedi. La fame spingeva a gesti che in condizioni normali sarebbero stati impensabili. La colonna si allungava, si sfilacciava, lasciandosi dietro una scia di corpi che il gelo avrebbe conservato fino alla primavera.
Eppure, in mezzo all’inferno, emersero storie di solidarietà che i reduci avrebbero tramandato per decenni. Ufficiali che dividevano l’ultimo pezzo di pane con i soldati, commilitoni che si trascinavano a vicenda, piccoli gruppi che combattevano insieme per non arrendersi. Era l’unico modo per sopravvivere.
La battaglia di Nikolajevka: l’ultimo ostacolo
Ventisei gennaio 1943. I resti del Corpo d’armata alpino, la Tridentina ancora in grado di combattere, brandelli della Julia e della Cuneense, arrivano davanti a un villaggio che si chiama Nikolajevka (oggi Livenka). I sovietici si sono trincerati lì, dietro il terrapieno della ferrovia, per chiudere la trappola.
Quarantamila uomini, molti disarmati, molti con i piedi fasciati in stracci perché le scarpe si sono sfatte da giorni, si trovano davanti all’ultimo sbarramento. Se non passano entro sera, il gelo della notte li ucciderà tutti. Non c’è alternativa.
Gli alpini attaccano dalla mattina. Il Verona, il Val Chiese, il Vestone si lanciano contro le posizioni russe, raggiungono la ferrovia, entrano nelle prime isbe del paese. Ma i sovietici contrattaccano, e le perdite sono terribili. A metà pomeriggio la situazione è in stallo, e il sole comincia a scendere.
È a quel punto che il generale Reverberi, comandante della Tridentina, sale su un semovente tedesco. Nel frastuono della battaglia, il suo grido, “Tridentina, avanti!”, passa di bocca in bocca, rimbalza lungo la colonna. E la massa dei superstiti, alpini e sbandati mescolati insieme, si riversa sulle posizioni sovietiche come un’onda. Alle cinque del pomeriggio Nikolajevka è superata.
Chi non è passato con quella carica non passerà più. Il giorno dopo la Cuneense viene catturata quasi per intero a Valuiki. Della Vicenza non resta quasi nulla. Ma la Tridentina, e con lei alcune migliaia di altri, ce l’ha fatta.
Il bilancio della catastrofe
I numeri dicono tutto. Dei 229.000 uomini partiti per la Russia, 84.830 risultarono caduti o dispersi, altri 29.690 furono rimpatriati perché feriti o congelati. Più della metà dell’Armata. Il Corpo alpino, che il 16 gennaio contava ancora 61.155 effettivi, vide uscire dalla sacca solo 13.420 uomini validi più 7.500 tra feriti e congelati.
E la tragedia non finì con la battaglia. Dei circa 68.000 italiani finiti prigionieri, ventimila morirono già durante le marce verso i campi, marce a piedi, nel gelo, senza cibo né cure. Altri 27.000 morirono nei lager, di tifo, di fame, di stenti. Tornarono a casa in diecimila, forse meno. Le famiglie degli altri aspettarono per anni notizie che non arrivarono mai, o arrivarono troppo tardi.
Le responsabilità
Di chi fu la colpa? La domanda è rimasta sospesa per decenni, e le risposte non sono semplici.
A Roma, Mussolini volle a tutti i costi partecipare alla “crociata antibolscevica”, questione di prestigio, di peso nelle future spartizioni. Mandò un’armata senza assicurarsi che fosse equipaggiata per sopravvivere, figuriamoci per combattere. I rapporti allarmati dei generali finirono nei cassetti.
A Berlino e nei comandi del Gruppo d’armate B, gli italiani erano considerati poco più di un fastidio. Quando servì spostare truppe per tamponare Stalingrado, le riserve vennero tolte dal settore dell’ARMIR senza troppi scrupoli. Tanto erano solo italiani.
Sul campo, l’ordine di ripiegamento per gli alpini arrivò con un ritardo che costò migliaia di vite. Il 17 gennaio, quando le divisioni alpine cominciarono a muoversi, i russi erano già alle loro spalle. Quel ritardo non è mai stato spiegato in modo convincente.
L’eredità della battaglia
La disfatta del Don segnò un punto di non ritorno. Non solo per le perdite, le più alte di tutta la guerra per l’esercito italiano, ma per quello che significarono. Dopo il Don, l’Italia fascista era finita. Lo sapeva Mussolini, che provò inutilmente a convincere Hitler a cercare un accordo con Stalin. Lo sapevano i generali. Lo sapevano, soprattutto, le famiglie dei soldati che non sarebbero tornati.
Poi vennero i libri. Rigoni Stern, Revelli, Bedeschi, Corradi, uomini che erano stati là e che sentirono il dovere di raccontare. Le loro pagine hanno tenuto viva una memoria che rischiava di perdersi, trasformando la tragedia in letteratura senza mai tradirla.
Dal 2022, il 26 gennaio è Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini. Una ricorrenza che non celebra la guerra, sarebbe osceno, ma ricorda chi la subì. Quei ragazzi partiti per un fronte lontano tremila chilometri da casa, convinti di tornare in pochi mesi, e rimasti per sempre nella steppa.
A oltre ottant’anni di distanza, la lezione del Don conserva intatta la sua attualità. Nessun eroismo individuale può supplire a errori di pianificazione strategica, a carenze logistiche croniche, a decisioni politiche prese senza alcun riguardo per chi avrebbe dovuto pagarne il prezzo. Quei ragazzi mandati a morire nelle steppe ghiacciate meritano di essere ricordati, non per celebrare la guerra, ma perché il loro sacrificio ci obbliga a non dimenticare quanto costa l’incoscienza di chi comanda.
Per approfondire: due libri da non perdere

Centomila gavette di ghiaccio
Bedeschi era ufficiale medico della Julia, e la sua è una prospettiva diversa: quella di chi curava i feriti senza medicine, di chi vedeva arrivare i congelati sapendo di non poterli salvare. Un romanzo corale, costruito sulle voci di decine di personaggi, che restituisce la dimensione collettiva della tragedia. Più lungo e articolato di Rigoni Stern, ma altrettanto potente. Vinse il Premio Bancarella nel 1963 e da allora non ha mai smesso di essere ristampato.

Il sergente nella neve-Ritorno sul Don
Non è un libro di storia, è la storia stessa che parla. Rigoni Stern era un sergente maggiore del Vestone quando attraversò Nikolajevka, e quello che racconta non l’ha letto da nessuna parte: l’ha vissuto. Pagine asciutte, senza retorica, dove il gelo e la fame e la paura diventano concreti come il fucile che ti pesa sulle spalle. Un capolavoro della letteratura italiana del Novecento, tradotto in tutto il mondo, che si legge in un pomeriggio e non si dimentica più.
Fonti e riferimenti
Fonti archivistiche e istituzionali:
- Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, documentazione sulla Campagna di Russia
- Archivio Storico della Presidenza della Repubblica: https://archivio.quirinale.it/aspr/gianni-bisiach/AV-002-000520/17-dicembre-1942-fine-armir
Studi e approfondimenti:
- Portale “Fronte del Don”: https://www.frontedeldon.it/homepage/
- “Un italiano in Russia” – Ricostruzione dettagliata delle operazioni dell’ARMIR: https://www.unitalianoinrussia.it/
- Gotica Toscana, “La Campagna di Russia, 70° anniversario”: https://www.goticatoscana.eu/it/portfolio/la-campagna-di-russia-70-anniversario/
- Museo Nazionale degli Alpini, commemorazione battaglia di Nikolajevka: https://www.museonazionalealpini.it/
Testimonianze e memorialistica:
- Rigoni Stern M., Il sergente nella neve, Einaudi
- Bedeschi G., Centomila gavette di ghiaccio, Mursia
- Revelli N., testimonianza su Nikolajevka: http://www.istitutodelnastroazzurro.org/2020/01/26/nikolajewka-26-gennaio-1943/
- Sezione ANA “Monte Suello”, ricostruzione della battaglia: https://www.montesuello.it/gli-alpini/18-noi-alpini/53-la-battaglia-di-nikolajewka.html
Voci enciclopediche:
Wikipedia, “8ª Armata (Regio Esercito)”: https://it.wikipedia.org/wiki/ARMIR
Wikipedia, “Seconda battaglia difensiva del Don”: https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_battaglia_difensiva_del_Don
Wikipedia, “Battaglia di Arbuzovka”: https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Arbuzovka
Wikipedia, “Battaglia di Nikolaevka”: https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Nikolaevka
L’articolo La Seconda battaglia difensiva del Don: anatomia di una catastrofe militare proviene da Difesa Online.
L’ARMIR sul fronte orientale tra errori strategici, carenze logistiche e il sacrificio dei soldati italiani
L’articolo La Seconda battaglia difensiva del Don: anatomia di una catastrofe militare proviene da Difesa Online.
Per approfondimenti consulta la fonte
Go to Source