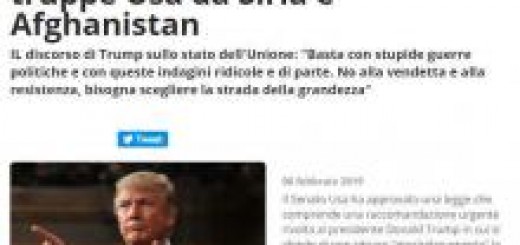La NATO, l’UE e l’Indo‑Pacifico in fermento
Nelle giornate del 17 e 18 giugno 2025, si è tenuta a Roma la Conferenza “Indo-Pacific 2025: Prevention and Dialogue”, organizzata dalla NATO Defense College Foundation. L’evento ha riunito esperti, diplomatici e rappresentanti di numerose istituzioni per discutere le mutevoli dinamiche dell’Indo-Pacifico, la sua crescente rilevanza per i Paesi dell’area euro-atlantica e le strategie per promuovere la cooperazione e prevenire i conflitti in questa regione vitale.
Oggi l’Indo-Pacifico appare un’area in fermento, possibile epicentro geopolitico di questo secolo, dove s’intrecciano cooperazione, competizione e nuove minacce. Se da un lato, l’area registra una significativa crescita – in termini demografici essa è sede di oltre la metà della popolazione mondiale, mentre in termini economici rappresenta una quota significativa del PIL mondiale, nonché principale snodo per il commercio – dall’altro, si configura come teatro di tensioni, equilibri di potere che si muovono e forte competizione strategica.
Proprio per questo motivo, il dibattito era teso a individuare le principali dinamiche di contesto, al fine di evidenziare il crescente ruolo dell’Indo-Pacifico nella visione globale della NATO e dei suoi partner. L’Alleanza, infatti, pur non essendo un attore principale sul campo e pur mantenendo saldo il proprio mandato euro-atlantico, ha definito l’impegno dell’Indo Pacifico come una necessità strategica, ribandendo la volontà di rafforzare le cooperazioni non solo con gli storici partner regionali che sono i cosiddetti “IP4”: Australia, Giappone, Repubblica di Corea e Nuova Zelanda ma anche con tutti gli altri possibili interlocutori dell’area, all’interno di un’architettura di sicurezza inclusiva, nella consapevolezza che le questioni militari, tecnologiche, economiche e ambientali in quest’area abbiano ricadute dirette sulla stabilità globale.
L’integrazione e la costruzione di relazioni stabili e trasparenti sono ritenute essenziali per affrontare al meglio quelle che sono state individuate come le tre minacce più realistiche: l’insicurezza ambientale, in quanto le sfide climatiche e ambientali sono ormai centrali per la stabilità della regione più esposta al climate change, richiedendo risposte condivise e resilienti; le minacce ibride e la disinformazione, che rendono necessario un potenziamento della cyber-resilience e la creazione di centri regionali per contrastare tali minacce; lo sviluppo economico inclusivo, considerato strumento di prevenzione dei conflitti, poiché promuove un’economia aperta e digitale, tutelando le rotte marittime e le catene del valore.
Alle tematiche legate allo sviluppo di partnership nell’Indo-Pacifico, è stato dedicato il primo panel della conferenza, dal quale è emersa l’urgenza di superare la frammentazione attuale nell’area, dove l’assenza di una visione condivisa di sicurezza e di un’architettura multilaterale solida, porta all’esclusiva costituzione di alleanze bilaterali e coalizioni ad hoc che si sovrappongono senza coerenza, aumentando tensioni e rischi di escalation. In quest’ambito è perciò necessario fare attenzione alla contrapposizione tra partnership positive e negative: le prime, fondate sulla creazione di valore aggiunto indipendente da qualsiasi fattore esterno, mirano a superare i limiti esistenti e a valorizzare le potenzialità delle società coinvolte; mentre le seconde, costruite in opposizione a un fattore esterno specifico o a una minaccia comune, funzionano come strumenti di contenimento, ma rischiano di perdere coesione se la minaccia rimane latente troppo a lungo. Come esempio positivo è stata citata l’iniziativa NATO-IP4, che dimostra la possibilità di stabilire obiettivi misurabili per una partnership di sicurezza nell’Indo-Pacifico, seppur con la necessità di renderla più inclusiva e capace di dialogare con chi è esterno ai partenariati attuali.
Inoltre, si è evidenziato che il modello di sicurezza collettiva, ben radicata in Europa, incontra resistenze culturali nell’Indo-Pacifico, dove è vista con diffidenza, sebbene partnership trilaterali e multilaterali si stiano intensificando (USA-Giappone-Corea del Sud, USA-Giappone-Filippine-Australia). Durante gli ultimi anni sono stati rafforzati numerosi accordi di difesa nella regione, ma permane una “asimmetria”: mentre agli europei si chiede di aumentare la spesa per la difesa, gli USA forniscono assistenza di sicurezza unilaterale nell’Indo-Pacifico, creando incoerenze strategiche. La sicurezza collettiva nell’Indo-Pacifico è vista come la via più logica per alleggerire il peso sugli USA e rafforzare la resilienza regionale, ma permane una diffidenza per la questione dell’autonomia strategica, soprattutto in India e nei Paesi dell’ASEAN. L’approdo più realistico per la sicurezza collettiva nella regione potrebbe essere un’organizzazione tipo “IPTO” (Indo-Pacific Treaty Organization) che apprenda dall’esperienza NATO, senza però alimentare timori di espansione occidentale, mantenendo una collaborazione strutturata con i partners chiave e ricordando che l’Indo-Pacifico è un dominio prevalentemente marittimo, con problematiche specifiche che richiedono attenzione.
Nei fatti, l’evoluzione dell’impegno della NATO nello scenario si fonda sui partenariati iniziati negli anni ’90 e formalizzati con gli IP4 nel 2010, oltre che sulla capacità di affrontare la sfida cinese. Dal 2019 la Cina Popolare è entrata nelle agende strategiche NATO, con il riconoscimento che le dinamiche indo-pacifiche influenzano la sicurezza euro-atlantica. In questo scenario, la Repubblica di Cina – Taiwan emerge come naturale partner tecnologico e attore chiave per la sicurezza regionale per tre motivi: posizione strategica nella prima catena d’isole di fronte alla Cina, ruolo dominante nella produzione di semiconduttori avanzati e status di democrazia con valori condivisi con i Paesi Occidentali. Per tali ragioni, sono state discusse proposte per includere Taiwan in formule come NATO Plus o Quad Plus, o nel secondo pilastro del patto di AUKUS per la condivisione tecnologica. Altre forme di collaborazione dell’Alleanza Atlantica con Taiwan potrebbero passare attraverso la formula EOP (Enhanced Opportunities Partner) all’interno della Science and Technology Organization (STO), per costruire resilienza nelle catene di approvvigionamento, mantenendo al contempo un equilibrio tra cooperazione e rispetto dei vincoli politici regionali.
Per affermare l’utilità delle partnership con i principali attori nella regione, sono state evidenziate nel corso della conferenza le sfide future cui si andrà incontro: Il ritorno della competizione geopolitica, il cambiamento climatico, la fragilità di alcuni stati e le attività criminali transnazionali – dalla pirateria al traffico di droga, dal terrorismo marittimo alla pesca illegale e al fenomeno del “sea jihad” – alimentano un’instabilità persistente. Anche l’Unione Europea si è dimostrata sensibile a queste tematiche, attivandosi con missioni civili, cercando di fornire un contributo nella lotta contro la criminalità organizzata, mostrandosi interessata alla protezione delle rotte marittime e alla partecipazione ai forum interministeriali regionali. La priorità dovrà quindi essere quella di riformare il settore sicurezza per adattarsi alle minacce multi dominio (terra, mare, aria, cyber, spazio), promuovendo la condivisione di conoscenze operative tra attori regionali e globali e delineando una divisione del lavoro tra organizzazioni multilaterali, dove l’UE può guidare la cooperazione industriale e la costruzione di capacità civili, mentre la NA può concentrarsi sulla pianificazione della difesa e sulla deterrenza. Per evitare Il rischio di sovrapposizioni tra organizzazioni dovranno essere promosse partnership complementari e multilivello, per affrontare in modo strutturato e sostenibile le sfide che l’Indo-Pacifico pone al sistema internazionale, confermando che solo attraverso una cooperazione intelligente sarà possibile garantire sicurezza, stabilità e sviluppo condiviso nella regione nei prossimi anni.
Il secondo panel ha affrontato il tema delle minacce ibride, considerandole una delle sfide più complesse e pervasive nell’Indo-Pacifico contemporaneo. I relatori hanno messo in evidenza come la guerra ibrida non sia più un’eccezione ma una forma dominante di confronto geopolitico, che fonde strumenti militari, tecnologici, informativi, normativi ed economici. In tale contesto, una prospettiva interessante è data dal come potrebbe evolvere il rischio di un conflitto nello Stretto di Taiwan, collegandosi alle lezioni apprese dalla guerra in Ucraina. Come noto, un’eventuale aggressione a Taiwan avrebbe ripercussioni gravi anche per l’Europa, sia per il ruolo centrale dell’isola nella produzione globale di semiconduttori, sia per il traffico commerciale che transita in quell’area, oltre che per la presenza di migliaia di cittadini europei sull’isola. La possibilità che tale crisi si verifichi è stata prospettata citando la cosiddetta “Davidson Window”, espressione formulata dall’ammiraglio Philip S. Davidson, ex comandante del U.S. Indo-Pacific Command: ossia l’ipotesi che la Cina Popolare possa agire entro il 2027. L’osservazione di alcune attività sospette permette, in realtà già oggi, la possibilità di affermare che il conflitto sia in corso in forma cibernetica, infatti, gruppi sponsorizzati da Pechino starebbero prendendo di mira infrastrutture critiche in vari paesi. Tuttavia, a differenza dell’Ucraina che ha potuto rafforzare le proprie difese informatiche prima dell’invasione, la democratica Taiwan potrebbe non avere lo stesso margine temporale, anche a causa della sua vulnerabilità rispetto ai cavi sottomarini, da cui dipendono le comunicazioni.
Il tema della guerra ibrida nell’Indo-Pacifico è quindi già una realtà quotidiana, con esempi che vanno dagli attacchi informatici e deepfake contro Taiwan, alle tensioni tra Cina Popolare e India e alle interferenze in aree come la Nuova Caledonia. Dal canto loro, NATO e Unione Europea hanno più recentemente riconosciuto la guerra ibrida come minaccia strategica, creando strumenti e squadre dedicate, e collaborando anche grazie ai 23 Stati membri comuni. Da questa esperienza europea è emersa nel dibattito la proposta di istituire un Centro di eccellenza per il contrasto alla guerra ibrida anche nell’Indo-Pacifico, suggerendo che l’Australia, per le sue relazioni con la NATO, l’esperienza maturata contro attacchi ibridi e la sua posizione nella regione, sarebbe un candidato ideale per ospitarlo. Un simile centro rafforzerebbe le capacità di risposta collettiva nella regione e favorirebbe la cooperazione tra Paesi Occidentali e attori locali.
Una terza prospettiva ha richiamato l’attenzione sulla minaccia alle democrazie e alle libertà fondamentali rappresentata dalla Cina Popolare, che analogamente alla Russia, utilizza sempre più spesso il diritto internazionale come arma strategica. In effetti, Pechino ha codificato nella propria dottrina la “guerra legale”, ovvero l’utilizzo del diritto per raggiungere obiettivi strategici senza ricorrere a conflitti armati diretti, come purtrppo avvenuto a Hong Kong o nel Mar Cinese Meridionale. Un’analisi realistica dei fenomeni degli ultimi anni fa emergere come la guerra ibrida cinese si giochi su tre fronti: le tattiche legali, quelle psicologiche e quelle di manipolazione dell’opinione pubblica. È auspicabile quindi che per difendere i valori democratici, l’Europa e i partner occidentali debbano smettere di illudersi che le potenze avversarie rispettino le regole, imparando a riconoscere e contrastare l’uso strumentale del diritto come arma nella competizione geopolitica globale.
Il terzo panel ha infine affrontato le nuove sfide, emergenti e mutevoli, sottolineando la necessità di soluzioni innovative e concrete che governino al meglio i fenomeni e le relazioni internazionali che si sviluppano dell’Indo-Pacifico. A tal scopo anche l’Unione Europea sta rafforzando la propria presenza attraverso un approccio olistico che integra sicurezza, sviluppo sostenibile e cooperazione multilaterale. L’UE ha intensificato le partnership con India, Giappone, ASEAN e altri attori regionali, promuovendo iniziative su transizione verde, digitale, sicurezza marittima e ordine internazionale basato su regole. In tal senso, si sottolineano i progressi della dimensione di sicurezza e difesa dell’UE nella regione, con esercitazioni navali con partner locali, nuove partnership di sicurezza con Giappone e Corea e un prossimo possibile accordo anche con l’India. Da qui è emerso come l’Unione Europea stia evolvendo da semplice attore economico a partner globale per la sicurezza, attento alla stabilità dell’Oceano Indiano e alla libertà di navigazione.
Un altro punto centrale emerso riguarda la crescente interconnessione tra terrorismo, traffici illeciti e pirateria nella regione, aggravati da fattori come la competizione geopolitica, la fragilità degli Stati, le conseguenze del Covid-19 e il cambiamento climatico. È stato analizzato il fenomeno della jihad marittimo e l’uso delle nuove tecnologie da parte dei gruppi criminali, che sfruttano droni, criptovalute e piattaforme online per traffici e attacchi. I successi ottenuti su questo fronte, nel contrasto al terrorismo marittimo, in particolare in Malesia e Indonesia, è stato possibile grazie a un approccio multidimensionale che unisce sicurezza e sviluppo. Proprio per questo, si pensa alla necessità di rafforzare la cooperazione informativa attraverso piattaforme regionali e agenzie internazionali, di incrementare la formazione, di contrastare la pesca illegale e di sviluppare strategie integrate di sicurezza marittima.
Infine, è stato ricordato come la capacità di adattamento alle sfide emergenti costituisca un segno di forza per istituzioni come NATO e UE. L’evoluzione della NATO dal focus su terra, mare e aria all’inclusione del dominio cyber, spazio e intelligence, mostra come le organizzazioni multilaterali possano rispondere a un mondo in rapida trasformazione, mantenendo la loro rilevanza. La resilienza delle democrazie che sostengono queste istituzioni consente di affrontare nuove minacce ibride, cyber e spaziali, ponendo l’accento sull’importanza del multilateralismo e della cooperazione per gestire rischi complessi che nessun attore può affrontare da solo.
Dai temi affrontati nel corso della Conferenza, è emerso come la stabilità dell’Indo-Pacifico sia ormai essenziale per la sicurezza globale, richiedendo cooperazione multilaterale e risposte innovative alle sfide emergenti. NATO e UE, rafforzando le partnership nella regione, potranno contribuire a garantire stabilità, prosperità e tutela dell’ordine internazionale nell’Indo-Pacifico nei prossimi anni.
In un momento storico caratterizzato da tensioni geopolitiche e minacce ibride, il vertice dell’Aia ha riconfermato il ruolo della NATO come pilastro della sicurezza collettiva. Allo stesso tempo, il tema della difesa è tornato al centro del dibattito dell’Unione Europea, rafforzando la necessità di creare un rapporto strategico tra l’UE e l’Alleanza Atlantica.
Con lo scopo di discutere questo rapporto strategico e il potenziale pilastro europeo della NATO, in un’ottica di complementarità strategica, per approfondire la rilevanza di queste dinamiche per gli interessi nazionali è stata organizzata una nuova Tavola Rotonda, che si terrà, in italiano, per offrire analisi approfondite contributi di alto livello su queste rilevanti tematiche, venerdì 11 luglio alle ore 18,00 presso il Circolo Affari Esteri.
Chi fosse interessato a partecipare e limitatamente ai posti ancora disponibili può inviare una email a : ndcf.conferences@gmail.com entro mercoledì prossimo.
Foto: China MoD
Per approfondimenti consulta la fonte
Go to Source